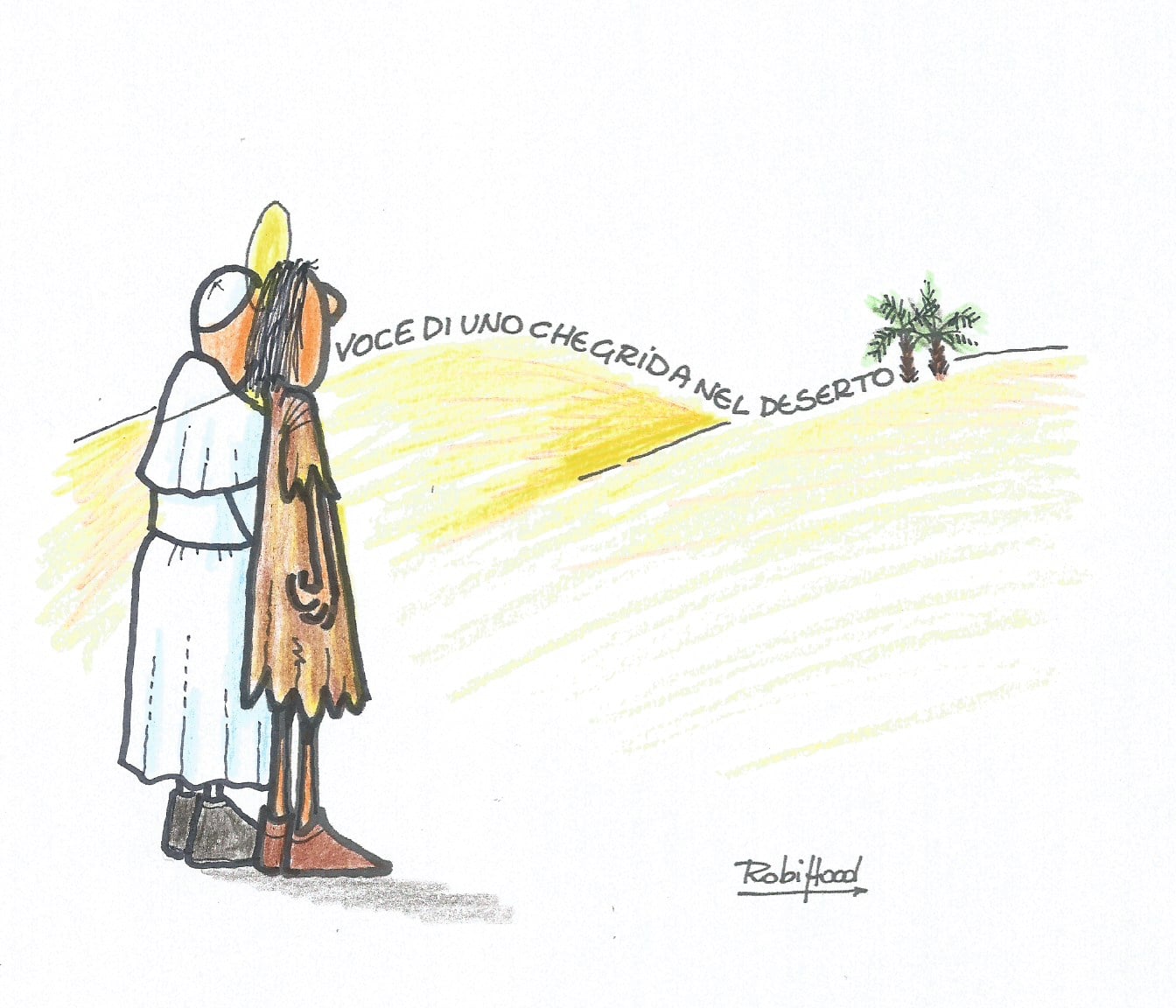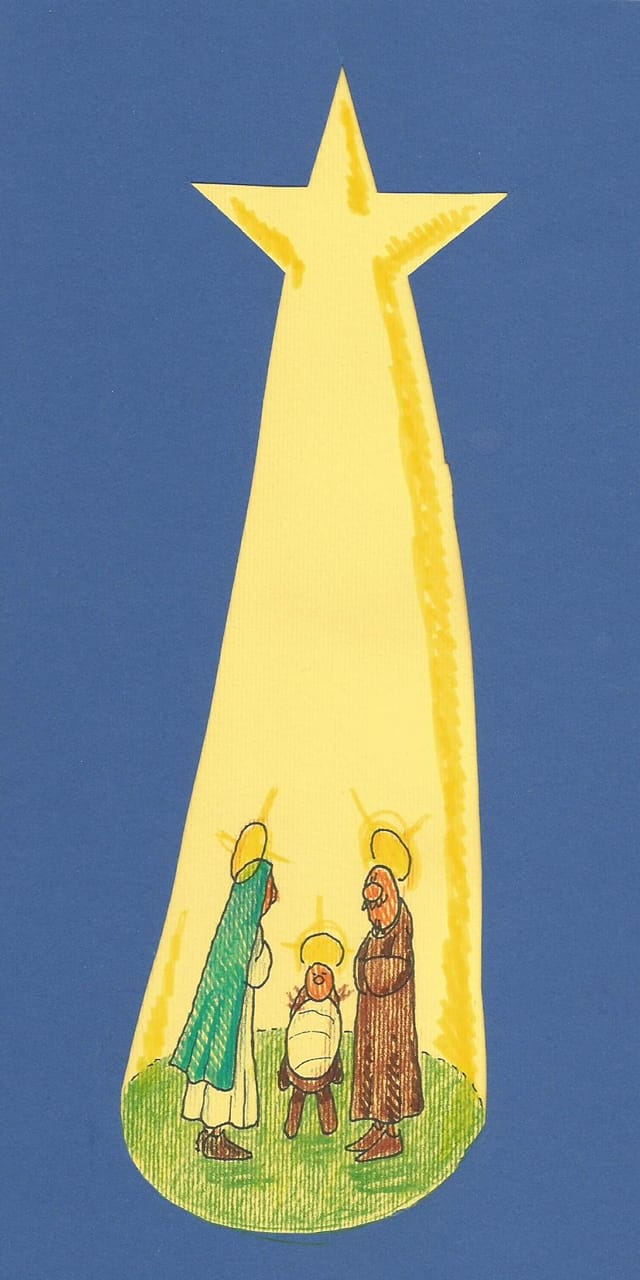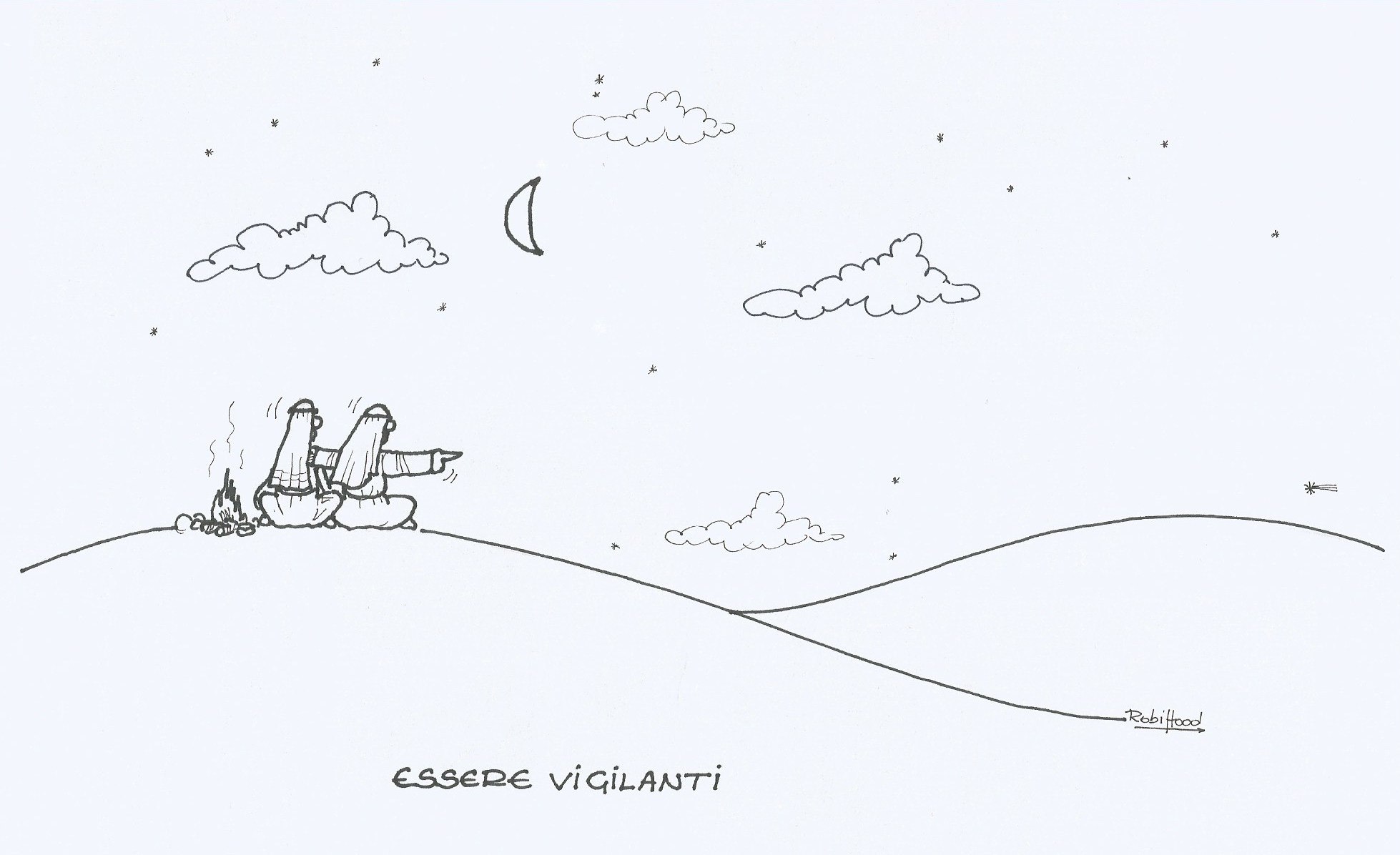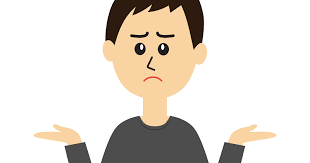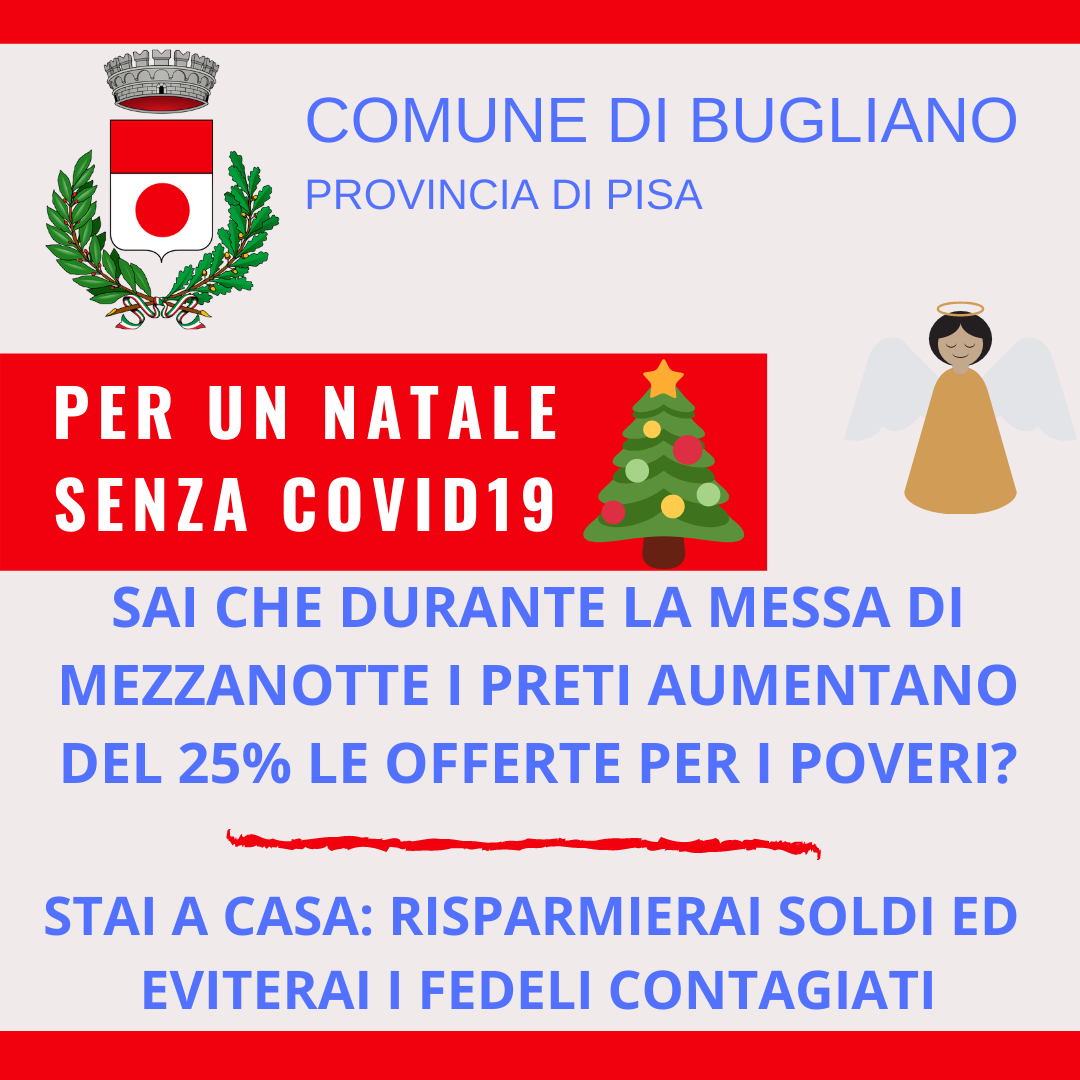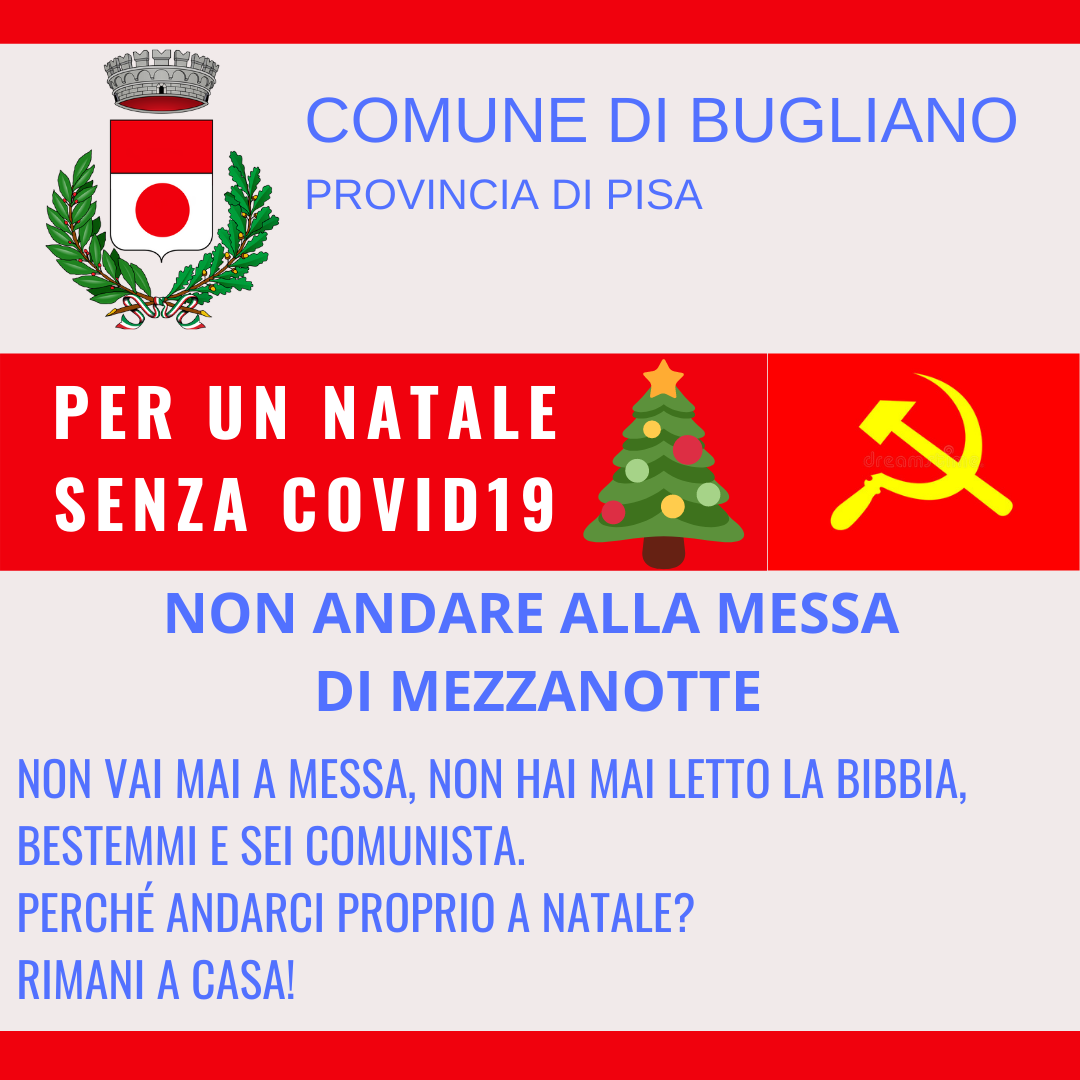2020_12_dicembre
- Dettagli
 (...) "Il Catechismo scrive: «Ogni avvenimento e ogni necessità può diventare motivo di ringraziamento» (n. 2638). *La preghiera di ringraziamento comincia sempre da qui: dal riconoscersi preceduti dalla grazia*. Siamo stati pensati prima che imparassimo a pensare; siamo stati amati prima che imparassimo ad amare; siamo stati desiderati prima che nel nostro cuore spuntasse un desiderio. Se guardiamo la vita così, allora il “grazie” diventa il motivo conduttore delle nostre giornate. Tante volte dimentichiamo pure di dire “grazie”.
(...) "Il Catechismo scrive: «Ogni avvenimento e ogni necessità può diventare motivo di ringraziamento» (n. 2638). *La preghiera di ringraziamento comincia sempre da qui: dal riconoscersi preceduti dalla grazia*. Siamo stati pensati prima che imparassimo a pensare; siamo stati amati prima che imparassimo ad amare; siamo stati desiderati prima che nel nostro cuore spuntasse un desiderio. Se guardiamo la vita così, allora il “grazie” diventa il motivo conduttore delle nostre giornate. Tante volte dimentichiamo pure di dire “grazie”.
Per noi cristiani il rendimento di grazie ha dato il nome al Sacramento più essenziale che ci sia: l’Eucaristia. La parola greca, infatti, significa proprio questo: ringraziamento. I cristiani, come tutti i credenti, benedicono Dio per il dono della vita. Vivere è anzitutto aver ricevuto la vita. Tutti nasciamo perché qualcuno ha desiderato per noi la vita. E questo è solo il primo di *una lunga serie di debiti che contraiamo vivendo. Debiti di riconoscenza*. Nella nostra esistenza, più di una persona ci ha guardato con occhi puri, gratuitamente. Spesso si tratta di educatori, catechisti, persone che hanno svolto il loro ruolo oltre la misura richiesta dal dovere. E hanno fatto sorgere in noi la gratitudine. Anche l’amicizia è un dono di cui essere sempre grati.
*Questo “grazie” che dobbiamo dire continuamente, questo grazie che il cristiano condivide con tutti, si dilata nell’incontro con Gesù*. I Vangeli attestano che il passaggio di Gesù suscitava spesso gioia e lode a Dio in coloro che lo incontravano. I racconti del Natale sono popolati di oranti con il cuore allargato per la venuta del Salvatore. E anche noi siamo stati chiamati a partecipare a questo immenso tripudio. (...)
Questo è il nocciolo: *quando tu ringrazi, esprimi la certezza di essere amato*. E questo è un passo grande: avere la certezza di essere amato. È *la scoperta dell’amore come forza che regge il mondo*. Dante direbbe: l’Amore «che move il sole e l’altre stelle” (Paradiso, XXXIII, 145). Non siamo più viandanti errabondi che vagano qua e là, no: *abbiamo una casa, dimoriamo in Cristo*, e da questa “dimora” contempliamo tutto il resto del mondo, ed esso ci appare infinitamente più bello. Siamo figli dell’amore, siamo fratelli dell’amore. Siamo uomini e donne di grazia.
Dunque, fratelli e sorelle, cerchiamo di stare sempre nella gioia dell’incontro con Gesù. Coltiviamo l’allegrezza. Invece il demonio, dopo averci illusi - con qualsiasi tentazione - ci lascia sempre tristi e soli. *Se siamo in Cristo, nessun peccato e nessuna minaccia ci potranno mai impedire di continuare con letizia il cammino, insieme a tanti compagni di strada*.
Soprattutto, non tralasciamo di ringraziare: *se siamo portatori di gratitudine, anche il mondo diventa migliore*, magari anche solo di poco, ma è ciò che basta per trasmettergli un po’ di speranza. Il mondo ha bisogno di speranza e con la gratitudine, con questo atteggiamento di dire grazie, noi trasmettiamo un po’ di speranza. Tutto è unito, tutto è legato e ciascuno può fare la sua parte là dove si trova. La strada della felicità è quella che San Paolo ha descritto alla fine di una delle sue lettere: «Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito» (1 Ts 5,17-19). No spegnere lo Spirito, bel programma di vita! *Non spegnere lo Spirito che abbiamo dentro ci porta alla gratitudine*.
*Catechesi di papa Francesco*, 30.12.2020
- Dettagli
Il 2020 è stato l'anno del "memento mori"
I morti silenziosi. Nudi, a faccia in giù con un tubo in gola e seppelliti in sordina.
Il 2020 è stato l'anno del "memento mori". Nessuno di noi, che non sia stato lambito dalla guerra, potrà ricordare un'ecatombe di portata simile. Quasi 70mila vittime, non per mano di un nemico in divisa, che potremmo permetterci anche di odiare. Sono state strozzate da un quasi nulla, un microscopico grumo, una pallina di pochi nano millimetri. Un filamento infinitesimale di RNA che abbiamo giocato a raffigurare come fiore velenoso con una corolla di glicoproteine, qualcosa sospeso tra un abbozzo di organismo e un ultra corpo alieno.
Allo scoppio della pandemia è cominciata a circolare la notizia di una strage; si moriva a grappoli, silenziosamente bombardati a tappeto dal Covid 19. Noi, che all'inizio ci sentivamo al sicuro nelle retrovie, abbiamo però pensato che la cosa ci riguardasse non più di tanto. Per esorcizzare un male concreto lo abbiamo spostato nell'universo delle narrazioni incrociate, ci siamo creati ad personam il simulacro della nostra paura, proprio come gli antichi ritraevano sotto la forma di demoni ungulati e cornuti le loro afflizioni senza spiegazione.
Abbiamo tutti contribuito al favoleggiare, fino a ridurre a un mito ambiguo quel virus incoronato. Intanto quello ha continuato a uccidere, moltiplicandosi e togliendo il respiro ai più fragili tra noi. Questo ci ha notevolmente destrutturato, solo però perché siamo stati costretti a riconsiderare grande parte delle nostre certezze, sedimentate su abitudini che consideravamo non più negoziabili. Il morire altrui per i più superficiali di noi era quindi ben poca cosa, di fronte alla libertà di muoversi per strada, di essere parte di una folla, di ballare, correre, abbracciare, scambiarsi fluidi e moine.
Questo è l'apice più atroce dei tanti coefficienti che hanno condannato all'esser salme desolate le vittime del Covid. Abbiamo invocato il diritto alla movida di fronte a carni che si raffreddavano lontane dalle lacrime di chi potesse rimpiangerle. Ci siamo industriati a cercare di fare tutto come se niente fosse accaduto, abbiamo finto di non vedere come
- Dettagli
papa Francesco, omelia della notte di Natale 2020
"La sua nascita è *per noi: per me, per te, per tutti* noi, per ciascuno. Per è la parola che ritorna in questa notte santa: «Un bambino è nato per noi», ha profetato Isaia; «Oggi è nato per noi il Salvatore», abbiamo ripetuto al Salmo; Gesù «ha dato se stesso per noi» (Tt 2,14), ha proclamato San Paolo; e l’angelo nel Vangelo ha annunciato: «Oggi è nato per voi un Salvatore» (Lc 2,11). Per me, per voi.
Ma che cosa vuole dirci questo per noi? Che il Figlio di Dio, il benedetto per natura, viene a farci figli benedetti per grazia. Sì, Dio viene al mondo come figlio *per renderci figli di Dio*. Che dono stupendo! Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascuno di noi: *“Tu sei una meraviglia”*. Sorella, fratello, non perderti d’animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, *sei mio figlio!*” Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: *“Coraggio, sono con te”*.
Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti *il punto di partenza di ogni tua rinascita: riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio*. Questo è il punto di partenza di qualsiasi rinascita. È questo il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che sorregge l’esistenza: al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell’inquietudine per il futuro, c’è questa verità: siamo figli amati.
E *l’amore di Dio per noi non dipende e non dipenderà mai da noi: è amore gratuito*. Questa notte non trova spiegazione in altra parte: soltanto, la grazia. Tutto è grazia. Il dono è gratuito, senza merito di ognuno di noi, pura grazia. Stanotte, ci ha detto san Paolo, «è apparsa infatti la grazia di Dio» (Tt 2,11). Niente è più prezioso.
(...) Viene un dubbio: il Signore ha fatto bene a donarci così tanto, fa bene a nutrire ancora fiducia in noi? Non ci sopravvaluta? *Sì, ci sopravvaluta, e lo fa perché ci ama da morire. Non riesce a non amarci*. È fatto così, è tanto diverso da noi. *Ci vuole bene sempre, più bene di quanto noi riusciamo ad averne per noi stessi*. È il suo segreto per entrare nel nostro cuore. Dio sa che *l’unico modo per salvarci, per risanarci dentro, è amarci: non c’è un altro modo*. Sa che noi miglioriamo solo accogliendo il suo amore instancabile, che non cambia, ma ci cambia. Solo l’amore di Gesù trasforma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera dai circoli viziosi dell’insoddisfazione, della rabbia e della lamentela. (...)
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20201224_omelia-natale.html
- Dettagli
Apprezzo quando qualcuno sa fare il suo mestiere (anche il pubblicitario).
Apprezzo quando si sa cogliere il proprio tempo e rileggerlo in modo creativo.
Apprezzo quando la nascita di una nuova vita è considerata una Bella Notizia!
- Dettagli
« ... E’ del tutto ragionevole che la eccezionalità dei tempi di “contagio” suggerisca ai pastori la possibilità di ricorrere alla “terza forma” del sacramento della penitenza. A maggior ragione ciò può essere consigliabile nel momento in cui si avvicina uno dei due appuntamenti (Natale e Pasqua) che attira il maggior numero di penitenti lungo l’anno liturgico. Il rituale mette a disposizione la III forma di qualsiasi pastore. Ma l’utilizzo è subordinato ad una valutazione che spetta al Vescovo. Ovviamente, trattandosi di un rito che interviene “in casi eccezionali”, non sempre la eccezionalità è prevedibile.
Nel caso specifico, una riflessione, iniziata da marzo scorso, ha preparato il campo a decisioni ragionevoli, che vengono a porsi in modo armonico con quelle più immediate, in relazione alla scorsa pasqua, che avevano preferito ricorrere al concetto di “votum sacramenti”, spostando la dinamica sul piano del “desiderio della coscienza del singolo”, impedito dalla condizione di presidio sanitario, piuttosto che sul piano di una confessione/assoluzione generale. Considerata la recezione di questo nuovo orientamento, vorrei segnalare una serie di questioni che potrebbero essere considerate in questo ambito:
a) Il distanziamento e la comunità di perdono
Il modello adottato durante il “lockdown duro” di marzo-maggio ricorreva al tema del “desiderio di confessione”, del “votum sacramenti”. Oggi si pensa alla “terza forma” del sacramento, che ha altri vantaggi, ma limiti almeno altrettanto gravi. Poiché presuppone una qualche forma di “raduno”, anche se non esige le forme dell’avvicinamento individuale al singolo confessore. Per questo, però, incontra la difficoltà di “grandi raduni”, sia pure distanziati, sul modello del raduno eucaristico.
b) La difficile penitenza nella esperienza generale di confessione
Un secondo punto da considerare è il seguente: se il “votum sacramenti” patisce il limite della mancanza di interlocutore ecclesiale, la “terza forma” del sacramento è un consistente e autorevole annuncio del perdono a cui non corrisponde però, necessariamente, né la elaborazione della parola personale né il lavoro sulla libertà. E questo, lo si deve riconoscere, non è un limite da poco.
c) La forza della parola di perdono e la fragilità della risposta
D’altra parte, nella condizione di sofferenza comunitaria determinata dalla pandemia, la forza di
- Dettagli
«Quale forza contenuta nella cosa donata fa sì che il donatario la ricambi?» si chiedeva all'inizio del secolo scorso Marcel Mauss. Possiamo oggi riproporre la domanda, ricordando però che la reciprocità che fonda l'economia del dono non si riduce a uno scambio tra due individui. La reciprocità genera un terzo elemento: la relazione. Se questa relazione sarà generativa, avremo un'economia del dono. Se si limiterà a un generico e momentaneo sfogo di buone intenzioni, non avremo generatività, ma stagnazione.
"La reciprocità è una costante nelle relazioni umane. Può essere quella negativa della vendetta – in cui viene ricambiato un colpo ricevuto – o quella positiva del dono. L’idea che il dono più autentico escluda la reciprocità mi sembra sbagliata e anche paradossale. Dopotutto, se c’è più gioia nel dare che nel ricevere, non sarebbe ingeneroso privare di questa gioia il destinatario del dono? Il bello del dono è che fa nascere il desiderio di dare a propria volta. Ma la reciprocità non prende sempre la forma di uno scambio diretto. Chi riceve un dono può farne uno a un terzo, alimentando così una catena di reciprocità positiva che coinvolge sempre nuove persone" (Mark Anspack, antropologo).
segue: http://www.vita.it/it/article/2020/12/01/donare-e-un-rischio-che-dobbiamo-correre/157550/?fbclid=IwAR10f9nPL9zH3EhGcml3i_ZZr680P6fx1LeWHKgzVdcHd6c7Ob5QcOwKdkE
- Dettagli
Solo le pido a Dios
Solo chiedo a Dio
Que el dolor no me sea indiferente
Che il dolore non mi sia indifferente
Que la reseca muerte no me encuentre
Che la morte arida non mi trovi
Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente
Vuota e sola senza aver fatto a sufficienza
Solo le pido a Dios
Solo chiedo a Dio
Que lo injusto no me sea indiferente
Che l'ingiustizia non mi sia indifferente
Que no me abofeteen la otra mejilla
Che non mi schiaffeggino l'altra guancia
Después que una garra me arañó esta suerte
Dopo que un artiglio mi ha graffiato questa fortuna
Solo le pido a Dios
Solo chiedo a Dio
Que la guerra no me sea indiferente
Che la guerra non
- Dettagli
Un video - tratto dal film profetico "Habemus papam - che mi fa sorridere e mi fa piangere allo stesso tempo.
- Dettagli
Per l'inculturazione della liturgia. Il Messale in rito zairese. È il primo
papa Francesco, martedì 1 dicembre 2020
Pubblichiamo la prefazione del Pontefice al volume “Papa Francesco e il Messale Romano per le diocesi dello Zaire” (Libreria Editrice Vaticana, 228 pagine, 20 euro) curato da Rita Mboshu Kongo. Si tratta, come scrive lo stesso Bergoglio, di uno strumento per conoscere meglio il rito zairese (Zaire è l’ex nome della Repubblica Democratica del Congo), finora «l’unico rito inculturato della Chiesa latina approvato dopo il Concilio Vaticano II» e come tale «esempio di inculturazione liturgica».
Il volume curato da suor Rita Mboshu Kongo è uno strumento per conoscere approfonditamente diversi aspetti del Messale Romano per le diocesi dello Zaire. Il 1° dicembre 2019, prima domenica di Avvento, abbiamo celebrato l’Eucaristia secondo il « Missel Romain pour les diocèses du Zaïre », approvato dalla Congregazione per il Culto divino il 30 aprile 1988. Finora è l’unico rito inculturato della Chiesa latina approvato dopo il Concilio Vaticano II. Il rito zairese del Messale Romano è ritenuto come esempio di inculturazione liturgica. Si sente che nella celebrazione secondo il rito zairese vibra una cultura e una spiritualità animata da canti religiosi a ritmo africano, il suono dei tamburi e altri strumenti musicali che costituiscono un vero progresso nel radicamento del messaggio cristiano nell’anima congolese. Si tratta di una celebrazione gioiosa. È un vero luogo di incontro con Gesù. Si vive ciò che abbiamo scritto: « La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia » ( Evangelii gaudium 1). Nel volume c’è giustamente un richiamo alla necessità di andare più in profondità, a qualcosa che tocchi l’animo, il pensiero, la sensibi-lità, il mondo culturale delle persone. La liturgia deve toccare il cuore dei membri della Chiesa locale ed essere suggestiva. «Il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale», bensì, «restando pienamente se stesso, nella totale fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, esso porterà anche il volto delle tante culture e dei tanti popoli in cui
- Dettagli

Ma le ho sentite solo io, in ciascuna delle sacrestie in cui sono stato in ciascuna delle notti di Natale in cui ho vissuto la tradizionale (per nulla paragonabile alla Veglia pasquale!) "messa di mezzanotte", le espressioni acidule: «Chiesa piena di gente che non viene mai a messa»; «I soliti natalini»; «Sono qui solo per fare sfoggio degli abiti eleganti»; «Son qui per bere il vin brulè alla fine della messa»; «Metti tanto incenso nel turibolo, che a questi qui dà fastidio persino il fumo delle candele»; «Oh, due ore di celebrazione... non finiva più»?!
Santi abitatori di sacrestie... smemorati!
Io queste frasi non le dicevo, ma le ricordo bene.
don Chisciotte Mc, 201130
- Dettagli
Esiste la *messa "nella notte*, ma non è scritto da nessuna parte che debba essere alle ore 24. E se lo dice anche "Aleteia"...!
https://it.aleteia.org/2020/12/01/messa-natale-mezzanotte-storia-tradizione/?fbclid=IwAR15Hu06CPjqgROC5kYnatMjcDekWms6YV6v7PN4X_QLVSVUBrL5Se9Nv3o
- Dettagli
«Messe di notte, digiuno, luce elettrica, ordine pubblico e ordine morale. Può essere utile ricordare che fino alle riforme di Pio XII (1950) le celebrazioni eucaristiche di notte erano percepite come impossibili per molti motivi: obbligo di digiuno dalla mezzanotte precedente, ordine pubblico e assenza di illuminazione elettrica. Così voleva il Concilio di Trento...e noi spesso ci dimentichiamo di come era il mondo fino a 4 generazioni fa. Senza contare il giudizio morale sulle azioni notturne: il Card Siri nel 1951, suggeriva di riservare le veglie pasquali notturne, cui era contrario, solo per attori, circensi e prostitute... (...)
Il tratto che accomuna alcune posizioni del 1951 sulla Veglia e certe posizioni di oggi sulla Messa della notte di Natale è proprio la rigidità disciplinare e dottrinale: come allora si puntavano i piedi contro le nuove evidenze, restando nella inerzia dei comportamenti “acquisiti”, così oggi ci si irrigidisce sulle acquisizioni degli ultimi decenni, come se le nuove evidenze – di carattere pubblico e sanitario – fossero semplicemente un attentato alla identità e alla tradizione. Si usano le novità elaborate dalla riforma a partire dal 1950, sulla base non solo di antichi documenti, ma anche di nuove evidenze tecnologiche, culturali e teologiche, come se fossero dati arcaici e intoccabili, che la Chiesa da sempre avrebbe osservato. Ma non è così: la logica “trasgressiva” dei riti esige un altro approccio, mentre la Veglia pasquale e la Messa di mezzanotte vengono ridotte in questo modo a mere “occasioni disciplinari e apologetiche”: notte buia allora, notte buia oggi».
di Andrea Grillo, 2 dicembre 2020
Leggi l'intero articolo: http://www.cittadellaeditrice.com/munera/la-trasgressione-delle-tenebre-le-messe-di-notte-la-nuova-veglia-pasquale-e-una-lettera-del-cardinal-siri-del-1951/?fbclid=IwAR2ODzn-j7tHE_Lep6_TX9qCIKVTkVHFGA5_UKCHn3acgGKkrcSkyLB3als
- Dettagli
- Dettagli
"Ma ci pensate che bello: sono le ore 24,00 tra il 24 e il 25 dicembre. Tutte le famiglie sono in casa e si collegano fra loro e con il prete della parrocchia. Ogni famiglia davanti al presepe: si mette Gesù nella mangiatoia mentre viene letto il brano di Luca o di Matteo della Natività. Un momento di silenzio e chi vuole si prenota e legge una sua preghiera. Poi tutti assieme di canta "Tu scendi dalle stelle". Si termina facendosi gli auguri. Poi tutti a nanna".
Fiorenzo De Molli, 27.11.2020 su FB