2020_08_agosto
- Dettagli
 “Mi sono riappacificato col pensiero di dover morire quando ho compreso che senza la morte non arriveremmo mai a fare un atto di piena fiducia in Dio. Di fatto in ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre delle “uscite di sicurezza”. Invece la morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio”.
“Mi sono riappacificato col pensiero di dover morire quando ho compreso che senza la morte non arriveremmo mai a fare un atto di piena fiducia in Dio. Di fatto in ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre delle “uscite di sicurezza”. Invece la morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio”.
C.M. Martini, Corriere della sera, 3/10/2008
- Dettagli
«L'altro giorno, partecipando ad una eucaristia nelle mie montagne, è capitato un fatto (non tanto) strano. Il celebrante, durante la Preghiera Eucaristica, ha pronunciato la frase: «Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa Benedetto XVI, il vescovo Claudio, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento». Una signora, attentissima come forse non c'immagineremmo noi preti, ha alzato la voce dicendo: “Il Papa si chiama Francesco!” La gente si è voltata tutta verso di lei, il celebrante si è sorpreso della correzione, la signora non ha abbassato lo sguardo di un millimetro. “La signora che ha parlato prima – ha detto il prete dal microfono finita la messa – è pregata di venire in sacristia”. Lì, lui stesso, ha avuto la grazia di andare a scuola di teologia e di fede da una signora innamorata di Dio e della sua Chiesa. Tramite terza persona, le ho mandato un abbraccio forte-forte. Questo è il fatto. Buona serata!». #sullastradadiemmaus
- Dettagli

Lo Spirito Santo, quello effuso dal Padre e dal Figlio, costituisce, esalta, accompagna e porta a compimento la libertà delle creature umane.
Mai le costringe, mai le sostituisce.
Nell’uomo, osservava san Tommaso d'Aquino, la grazia non distrugge la natura, ma ne porta a compimento le potenzialità: “Gratia non tollit naturam, sed perficit” (Summa Theologiae, I,1,8 ad 2)
E se la creatura "non est", lo Spirito cosa può perfezionare?!
Chi torna a spiegarlo di nuovo a tanti che pensano e operano come se così non fosse?
don Chisciotte Mc, 200828
- Dettagli
*Il sociale riscopra la spiritualità per tornare a cambiare il mondo*
Riccardo Bonacina intervista don Virginio Colmegna, 27.08.2020
Abbiamo una rivoluzione culturale da fare, dobbiamo recuperare il gusto di una politica radicata nell'etica e nel futuro. Ci sono due partite fondamentali su cui impegnarsi: salute ed educazione.
‘*Don Virginio Colmegna* da tempo sta meditando ogni mattina un paragrafo dell’enciclica di papa Francesco “Laudato si’” che quest’anno compie cinque anni. «È un’enciclica che ci offre anche un’invasione dei sentimenti oggi così corroborante perché il Covid rischia di farci inaridire. *Siamo tutti rannicchiati a difendere l’esistente senza capire che dobbiamo riaprirci, dobbiamo aprire le finestre della nostra anima, del nostro cuore e della nostra mente*. L’enciclica sin dalla prima pagina, se non siamo come zombie, ci fa sobbalzare con questa frase “La nostra casa comune è come una sorella con la quale condividiamo l’esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia”. Una frase che mi ripeto spesso». (…)
«È il fermento etico e spirituale che ci rende insopportabile l’ingiustizia e che ci mobilita per perseguirla. È questo fermento che ha dato vita anche alla grande innovazione del Terzo settore a metà anni Ottanta, non dimentichiamolo. Un Terzo settore che oggi rischia di schiacciarsi sulla gestione dei servizi, con tutta la tensione e pesantezza della sopravvivenza che ci spinge ad essere rete per resistere. Occorre invece *l’impeto della profezia che ha le sue radici, sempre, nella dimensione spirituale*. La radice spirituale è il presupposto non solo per una vita personale piena e una vita collettiva felice, ma anche per costruire anche una dinamica sociale e politica. È, mi pare un invito a finirla con la cultura dell’individualismo compiuto e con il paradigma tecnocratico. (…)
«Il valore della *gratuità sia elemento fondamentale capace di disegnare nuovi equilibri anche sociali*. Ora, il rischio è quello di essere spinti nell’angolo dei testimoni, testimoni di bontà; ci danno premi e pacche sulle spalle, dopo di che sembra che siamo incapaci di prendere in mano le istituzioni rigenerandole, per loro chiusura e nostre timidezze. Non possiamo neppure diventare gestori dell’emergenza. Il sociale, invece, deve sfidare la politica, con il suo sguardo sul futuro, con le sue utopie, con il senso del limite che la pratica sociale ti fa imparare. Ogni giorno
Leggi tutto: «Il sociale riscopra la spiritualità per tornare a cambiare il mondo»
- Dettagli

Gli incontri segreti tra ex terroristi e vittime: "Insieme nel nome del cardinal Martini".
“Come posso rendermi utile?”, chiese l’anziano e già malato arcivescovo prima che venisse scattata questa foto. Testimonianza delle prove di dialogo che sono continuate anche dopo la sua morte (nel 2012), “per aiutare a discutere chi aveva sparato e chi aveva subito il lutto”.
di Piero Colaprico
Era già molto malato, il cardinale Carlo Maria Martini, ma appoggiandosi al bastone arrivò nella sala dove l'aspettavano in tanti. Come ogni anno, aveva in faccia quella sua espressione che si può riassumere nel semplice "Come posso rendermi utile?". E scattarono una foto, destinata a restare segreta. C'è il cardinale in camicia e maglione azzurro, lo si vede al centro dell'immagine. Ma intorno a lui, a Viboldone, vicino Gallarate, dove Martini morirà nel 2012, sono riconoscibili alcune persone che in quest'Italia di divisioni e fazioni, di rancori e vendette, non ti aspetteresti mai di vedere insieme negli stessi pochi metri quadrati.
Il primo a sinistra, con la mano sul fianco, è Franco Bonisoli, ex brigatista rosso, direzione strategica, uno che nel 1978 partecipò alla strage di via Fani, in cui venne uccisa la scorta di Aldo Moro, e il presidente della Dc rapito. Vicino a Bonisoli, con la sciarpa bianca, c'è però Antonio Iosa, 82 anni, che dei brigatisti fu vittima: venne gambizzato, insieme ad altri tre, il martedì santo del 1980, e trentaquattro operazioni non gli tolgono ancora i dolori, quando cammina. Dietro i due, spunta Mario Ferrandi. È forse il principale protagonista di una giornata simbolo, il 14 maggio 1977, in cui venne scattata la foto del giovane mascherato che in via De Amicis a Milano spara ad altezza d'uomo. Morì l'agente Antonio Custra, e a sparargli, dopo aver dato l'ordine d'attacco "Romana fuori", fu proprio Ferrandi.
A destra nella fotografia con il cardinale malato, ma ben felice di essere là, perché anche quella era la sua vita, sono riconoscibili altri due uomini. Uno, più anziano, è un volto noto per ogni giornalista che abbia avuto a che fare con la stagione delle stragi e delle morti per terrorismo: Manlio Milani, sopravvissuto all'attentato fascista di piazza della Loggia a Brescia, 1974, in cui morì, tra gli altri, sua moglie Livia. Ultimo, invece, uno che non amava troppo mostrarsi in pubblico, Giorgio Semeria, ex capo brigatista, considerato il successore di Renato Curcio. Primo arresto nel 1972, passaggio alla clandestinità, omicidi, rivolte nelle carceri. Semeria è morto da poco, per un brutto tumore sbocciato nella stessa zona del corpo dove un detective gli sparò: "Mi hai sparato mentre ero ammanettato ", gli gridò al processo. Chissà, ma Semeria era molto cambiato, faceva catechesi, e chi l'ha visto morire dice che "se n'è andato sereno".
Tutte queste persone, e altre ancora, uomini e donne, rossi e neri, credenti e atei, a Roma come a Milano e in giro per l'Italia, sono
- Dettagli
Programmare. Cosa? Come? Ripensare modi e tempi della pastorale delle parrocchie
@ Diario di un prete
di Alberto Varinelli, 13 Agosto 2020
Di questi tempi, gli anni precedenti, ero alla conclusione delle settimane di vacanza con i ragazzi, sospese quest’anno per motivi di sicurezza, e gironzolavo per casa con le bozze fresche di stampa dell’agenda interparrocchiale, pronto a fare un lavoro certosino di revisione per evitare sovrapposizioni di attività, ripetizioni, errori.
Quest’anno… non ho tra le mani alcun foglio. Le uniche date fissate sono quelle di alcuni dei sacramenti dell’iniziazione cristiana che non abbiamo potuto celebrare nei mesi scorsi. Per il resto, nulla di certo.
Con il Covid in agguato non si sa se e cosa programmare. Questo è stato il tema di un bel momento di scambio di idee tra preti della nostra fraternità sacerdotale (Calepio-Sebino-fraternità 1), la scorsa settimana. Fondamentalmente, tutti abbiamo invocato il Santo più venerato in terra bergamasca, di questi tempi: San Fai (per i non bergamaschi, “san fai?” significa, in dialetto, “cosa facciamo?”, ndr). Programmare? Cosa? Come? Chi può sapere cosa accadrà nei prossimi mesi, quali saranno le misure di sicurezza dettate dai protocolli emanati dai vari enti pubblici, come muterà il virus? Nemmeno la scuola, di cui si continua ad affermare che riaprirà il 14 settembre, ma di cui le modalità concrete di ripartenza sono ancora, anche per noi docenti, un “mysterium fidei”, ci sta aiutando a tracciare orizzonti di futuro possibili.
Eppure, anche in questa incertezza, tra noi sacerdoti non manca l’entusiasmo, soprattutto perché, finalmente, la questione di una seria revisione della nostra pastorale ordinaria diventa non solo il centro della riflessione, ma anche dell’intenzione di effettuare interventi concreti.
E’ l’occasione di fermarsi e ripensare tutto. Da anni ci diciamo che occorre fermarsi un attimo, rileggere la nostra pastorale, discernere cosa è importante tenere, cosa lasciare, sulla base di criteri di senso; da anni ripetiamo che occorre lavorare di più insieme, perché la singola parrocchia, con sempre meno preti, non può più proporre tutto ciò che proponeva prima, ma, in un’ottica di fraternità e collaborazione, è bene che a livello zonale vengano proposte diverse attività, alle quali poi le diverse comunità o le singole persone possono fare riferimento.
Anche nelle singole parrocchie, penso alle mie di Grumello del Monte e Telgate… quante volte ci siamo confrontati sulla catechesi, su come essa sia sempre più difficoltosa e rischi di non far cogliere l’essenziale, dei rischi di ridurla a lezioni scolastiche staccate dalla vita, della difficoltà a far cogliere il legame vitale catechesi-sacramenti-preghiera-vita…
eppure, passarono gli anni, e fu sera e fu mattina, e tutto fu sempre come l’anno prima.
Ebbene, quest’anno, il tempo di incertezza può trasformarsi in tempo provvidenziale. Forse, finalmente, non più schiavi di un’agenda che cambiava la copertina, ma era la stessa dell’anno precedente, la novità suggerita dallo Spirito potrà trovare spazio. Se lo vogliamo, i prossimi mesi saranno tempo di lavoro intenso, un lavoro innanzitutto su di noi, sul nostro essere Chiesa, sulla pastorale. Come ho detto ai miei catechisti, non è un problema se la catechesi dei bambini e ragazzi dovesse ricominciare con l’Avvento: l’importante è che nei mesi precedenti, come catechisti e con la comunità, rileggiamo la nostra proposta, i suoi punti di forza e di criticità, per abbozzare un percorso rinnovato, che potrà essere testato da quando inizieremo e poi per tutto il prossimo anno pastorale, così che, l’anno successivo, potremo correggerlo e migliorare ulteriormente la proposta.
Sì, questo tempo è provvidenziale, se non cadiamo nella solita tentazione di riempire l’agenda, ma proviamo a riprendere in mano le questioni serie della fede, della catechesi e della pastorale, sotto la guida dello Spirito.
http://www.santalessandro.org/2020/08/13/programmare-cosa-come/
- Dettagli
 La Bibbia, acqua di sorgente
La Bibbia, acqua di sorgente
di Alessandro Esposito
Per tutta la tradizione ebraica, di cui lo stesso Gesù è figlio e per ciò stesso espressione, il rapporto con le Scritture si configura in questo modo: si tratta di una relazione vivente, di un reciproco, instancabile interrogarsi, che va dal testo a chi lo ascolta e viceversa. Non è materia inerte, il testo: al contrario, è cuore pulsante che alimenta una gioiosa irrequietezza, un desiderio che si rinnova a ogni nuovo ascolto e non si spegne nella spiegazione, ma si ridesta e si riaccende, ogni volta di nuovo, nel commento. Ogni testo, infatti, ogni racconto, è un invito a scavare, alla ricerca di sensi che fioriscono a ogni passo, custoditi nel cuore stesso di parole che sono come indizi che ci mettono sulle tracce di una ricerca che non ha fine e che si chiama fede.
Credere, difatti, significa rimanere viandanti, mantenere il cuore e la mente aperti a quel dono di novità in cui Dio si lascia incontrare, ma mai identificare una volta per tutte e, men che meno, imprigionare. Fede è freschezza che si alimenta di una lettura sempre rinnovata e mai conclusa, quella stessa che fa sì che, giorno dopo giorno, ci rechiamo presso una fonte che ci dona, al contempo, la sete e l'acqua. Questo è la Bibbia: acqua di sorgente che, mentre spegne la sete, torna a ridestarla. Noi ci accostiamo a questa fonte con le piccole anfore dei nostri cuori, che si ricolmano della sua acqua per poi svuotarsi e tornare ad attingere a lei, incessantemente. La nostra sete può placarsi, ma mai estinguersi: quella stessa Parola che la spegne, difatti, torna anche ad alimentarla.
Ma perché ciò avvenga, le Scritture vanno accostate, interrogate, interpretate: non sempre, difatti, la loro comprensione è immediata, come del resto accade con tutti gli incontri significativi che
- Dettagli
 La speranza si può imparare
La speranza si può imparare
di Giancristiano Desiderio
Un saggio dello psichiatra Eugenio Borgna esplora la «passione del possibile» (e il suo contrario). Oltre la medicina
Quante volte parlando con un amico o ragionando con noi stessi in un dialogo interiore concludiamo dicendo: «Speriamo»? Quasi sempre. Perché la speranza fa parte di noi più di quanto non siamo disposti ad ammettere ed accettare. Fa così parte della condizione umana, la speranza, che non solo è, come dice Foscolo nei Sepolcri, l'ultima dea a fuggire, ma è dalla sua fuga o dalla sua assenza che nasce la sorella o sorellastra: la disperazione.
Il filosofo danese Kierkegaard, il padre riconosciuto dell'esistenzialismo, distingueva tra angoscia e disperazione e mentre per la prima riconosceva una via di salvezza, per la seconda parlava di «malattia mortale» ossia lo stato in cui non si è né vivi né morti e ci si dispera. Accade, diceva l'autore di Aut-Aut, quando l'uomo rifiuta di essere una creatura e si concepisce come un essere perfettamente autonomo mentre gli esseri umani, che i Greci chiamavano i mortali, sono creature fragili.
È da qui che prende ispirazione Eugenio Borgna per il suo ultimo libro: Speranza e disperazione (Einaudi). Un testo per tutti perché, pur considerando i limiti propri della psichiatria, si rivolge ai comuni lettori che, speranzosi o disperati che siano, vanno alla ricerca di un ubi consistam e, più semplicemente, di fiducia.
Eugenio Borgna ha praticato la scienza psichiatrica sul campo — nel manicomio di Novara — e nel libro ritornano le esperienze cliniche dei pazienti, le loro testimonianze, i dolori, i drammi, le angosce e la ricerca nel tentativo di ascoltare e dare un senso alla vita. Tuttavia, proprio perché speranza e disperazione non riguardano solo casi estremi ma toccano le esistenze comuni, la vita che ci accomuna, Borgna porta la psichiatria oltre la psichiatria e incontra la letteratura, la filosofia, la poesia, che sono tutti modi o «vie» per esprimere le angosce umane e dare un senso di speranza alle nostre desideranti fragili vite.
Non a caso al centro del libro, così ricco di richiami e di rimandi, da Agostino a Pascal, da Kierkegaard a Jaspers, da Goethe a Benjamin, vi sono due letterati e poeti come Giacomo Leopardi e Cesare Pavese. Del primo si assume la «filosofia» di fondo, che apre proprio il volumetto di Borgna con una frase ripresa dallo Zibaldone: «Insomma la disperazione medesima non sussisterebbe senza la speranza, e l'uomo non dispererebbe se non isperasse». Eccole qui le due sorelle gemelle: speranza e disperazione. Figlie della stessa madre che, a volte, albergano nello stesso cuore, straziandolo.
Del secondo, di Cesare Pavese, si
- Dettagli
Un mix di sagacia, intelligenza, letteratura e capacità di scrivere! Una rarità. Da invidiare.
(p.s. Se c'è qualche espressione volgare... beh, non soffermatevi e passate oltre... se vi riesce!!).
dalla pagina FB "Non è successo niente"- 29 luglio 2020
- Achille!
- Re Agamennone in persona, a cosa devo l'onore?
- Stiamo per attaccare e volevo sapere se il più forte fra i nostri guerrieri è pronto a gettarsi nella mischia.
- Sono sempre pronto.
- È ciò che volevo sentire. Bene, ecco come procederemo: i carri da guerra e gli arcieri si muoveranno lungo una linea… che cos'è?
- Questa?
- Sì.
- È la mia armatura. Forgiata da Efesto in persona. Ti piace?
- No, bella è bella, ma scusa…
- Cosa?
- I copritalloni?
- Non li metto.
- Per favore, non cominciamo di nuovo con sto discorso.
- T'ho detto che non li metto e non li metto.
- Achille, per cortesia, una cosa t'ho chiesto! Una! Di mettere quei minchia di copritalloni!
- Coi copritalloni mi sento soffocare.
- È biologicamente impossibile sta cosa che ti senti soffocare dai talloni!
- Invece sì, io respiro molto coi piedi.
- Ascoltami, ragiona un secondo, te sei invincibile.
- Invincibilissimo.
- Issimo, sì, bravo. Tranne che in un punto.
- Un punto.
- E quel punto è…?
- È?
- No, dico, quel punto è?
- Il tallone?
- Il tallone! Mortacci tua! Puoi andarci fuori
- Dettagli
 Delicatezza. Intuizione e tatto
Delicatezza. Intuizione e tatto
di Nunzio Galantino
«Dovessi cercare un sinonimo della parola "delicatezza", non andrei oltre il termine "rispetto". Soprattutto perché lo ritengo, assieme all'intelligenza, la scaturigine di ogni gesto, di ogni sguardo e di ogni abbraccio delicati. Questi appartengono solo a chi è capace di "intus legere" il livello di sensibilità di chi gli sta di fronte. In modo da pronunziare parole che non feriscono, lanciare sguardi che non violano l'intimità e regalare abbracci che non soffocano.
La persona delicata è libera dal possesso, ma non dalla cura. Pone domande, con rispetto e senza pretese, restando in attesa che sia l'altro a farle dono della risposta; quella che questi decide di mettere in comune, perché si crei un ponte che unisce storie diverse.
La delicatezza si esprime attraverso scelte e atteggiamenti concreti: il rispetto dei tempi degli altri, specialmente quando si ha la responsabilità di una famiglia o di una comunità; fare un passo indietro, quando c'è l'eventualità di essere percepiti come ingombranti; tacere piuttosto che emettere solo suoni, per il gusto di dire la propria. In una parola, discrezione, secondo la Regola benedettina di saper discernere la misura giusta o il momento adatto.
«In Miltiade - scrive Cornelio Nepote (De viris illustribus, 8.4) - summa erat communitas». La communitas, per i latini, era la delicatezza. Trovar riconosciute insieme, nel comandante ateniese, summa communitas e capacità di grandi conquiste aiuta a capire che la delicatezza non è la qualità dei deboli. È una virtù che invece appartiene alla persona forte, che non ha bisogno di sopraffare l'altro per affermare la verità, per attirare l'attenzione su di sé o per creare relazioni significative. La delicatezza procura e dà soddisfazione: ha la stessa radice di "delizia".
Soprattutto nel dialogo, la delicatezza è molto di più della gentilezza e della cortesia. È l'insieme di intuizione, tatto e scelta delle parole giuste, dette con garbo. Possibile solo a chi, prima di prendersi cura degli altri, si prende cura di sé. Infatti non si può essere delicati con gli altri e con l'ambiente che ci circonda se non si è interiormente pacificati.
Non può essere delicato l'egoista, perché la delicatezza porta di per sé a osare la solidarietà e spinge a sviluppare l'attenzione verso l'altro, diventando la strada maestra per la costruzione di una società nella quale valga la pena di vivere. L'egoismo individuale e quello collettivo offuscano gli occhi. Al contrario, la delicatezza dona occhi per scorgere potenzialità nuove in chi mi sta di fronte e orecchie per farsi raggiungere dalla richiesta di rispetto proveniente dall'ambiente che mi circonda.
Per quanto la delicatezza vibri in noi a un ritmo diverso da quello della materia e delle cose materiali, ci permette di guardare l'una e le altre con un occhio che ne scopre e valorizza le potenzialità.
Che differenza infatti tra una musica ascoltata da una persona delicata e la stessa che invece raggiunge le orecchie di una persona rozza e insensibile!».
in "Il Sole 24 Ore " del 9 agosto 2020
- Dettagli
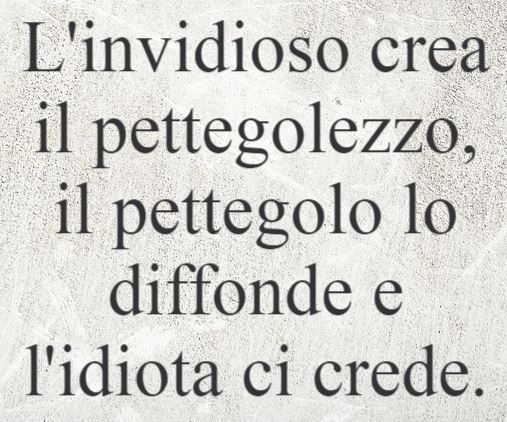 Mi sono fatto convinto che alcuni (non pochi, mi pare) ministri ordinati non abbiano modo migliore di trascorrere il tempo che spettegolando del prossimo, specie se si tratta di confratelli.
Mi sono fatto convinto che alcuni (non pochi, mi pare) ministri ordinati non abbiano modo migliore di trascorrere il tempo che spettegolando del prossimo, specie se si tratta di confratelli.
Oltre alla perdita di tempo, si può ben capire che questa montagna di informazioni false e confuse non mira alla verità (bensì al diletto, al passatempo), non fa del bene, non fornisce informazioni utili a nessuno, tantomeno all'autorità (se si fida e si affida a queste chiacchiere).
Questo è uno dei motivi per i quali se chicchessia desidera sapere come la penso su una questione, può leggere ciò che pubblico (libri, riviste teologiche, social, mail) o può contattarmi per un incontro (preferirei alla presenza di almeno un "garante" di ciò che viene detto).
Questo significa essere responsabili delle proprie azioni e delle proprie parole.
Altri modi di fare, non li ritengo affidabili, e mi rammarico che siano il pane quotidiano di non poche persone.
don Chisciotte Mc, 13.08.2020
« (...) Colui che, in una comunità, chiacchiera contro un fratello finisce per «volerlo uccidere», ha sottolineato il Pontefice. «L’apostolo Giovanni — ha ricordato — nella prima lettera, capitolo 3, al versetto 15, ci dice questo: colui che odia nel suo cuore suo fratello è un omicida». E il Papa ha subito aggiunto: «noi siamo abituati alle chiacchiere, ai pettegolezzi» e spesso trasformiamo le nostre comunità e anche la nostra famiglia in un «inferno», dove si manifesta questa forma di criminalità che porta a «uccidere il fratello e la sorella con la lingua».
«La Bibbia — ha proseguito il Papa — dice che il diavolo è entrato nel mondo per invidia. Una comunità, una famiglia viene distrutta da questa invidia che insegna il diavolo nel cuore e fa che uno parli male dell’altro». E riferendosi a quanto accade in questi giorni, ha sottolineato che bisogna pensare anche alle nostre armi quotidiane: «la lingua, le chiacchiere, lo spettegolare» (...).
Osservatore Romano, 2-3 settembre 2013
- Dettagli


«Questa madre ha partorito pochi minuti prima dell’esplosione di Beirut. Il bebè, Nabil, è nato tra le macerie, ma ha trovato subito amore e protezione tra le braccia di suo padre. È la storia a lieto fine di cui avevamo bisogno. (...)
Il piccolo Nabil è forte e in salute, un barlume di speranza in questi giorni bui. Il coraggio e l’empatia salveranno il mondo».
Nicolò Govoni, FaceBook 11.08.2020
- Dettagli
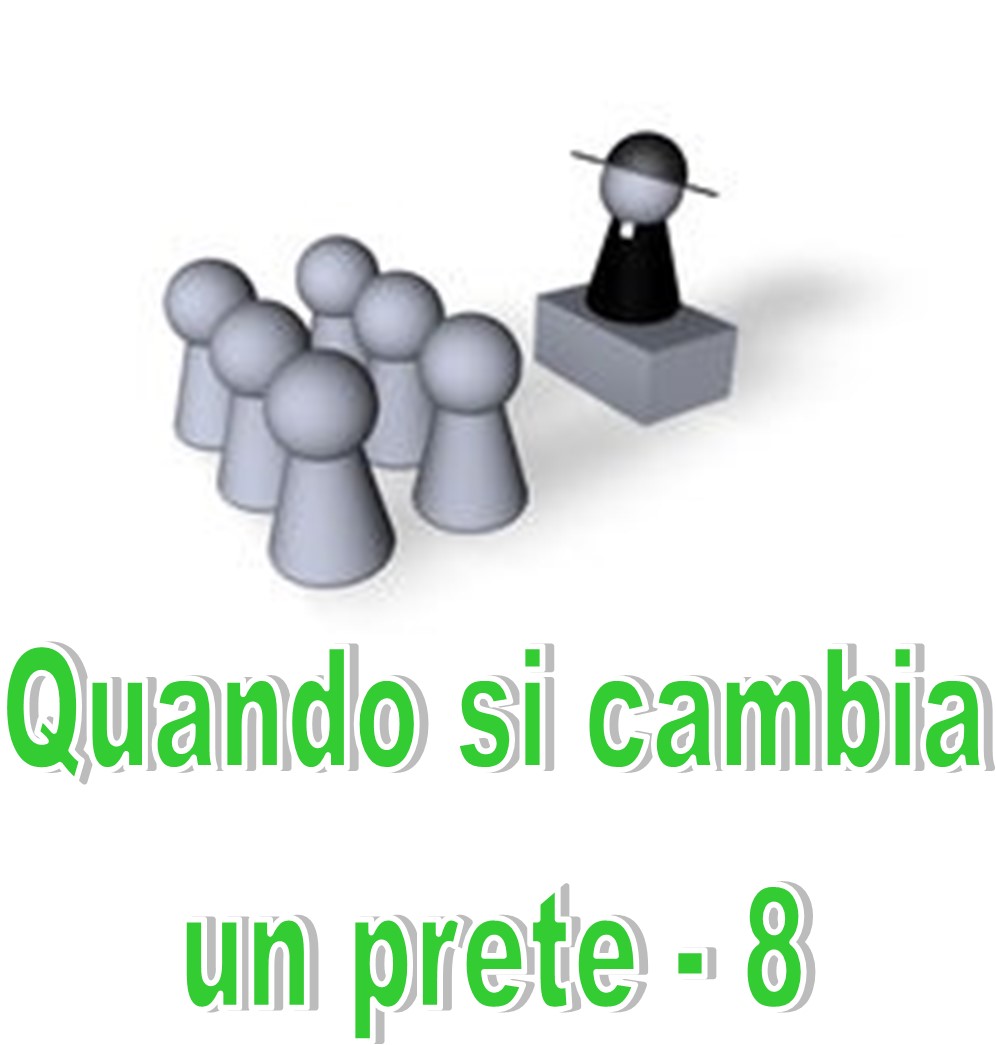 "Quando si cambia un prete" - 8
"Quando si cambia un prete" - 8
Quando vi è l'avvicendamento di un parroco (per un vescovo, non so), la curia avvia una visita nella parrocchia allo scopo di verificare la situazione economica.
Non altrettanto avviene per la situazione pastorale al momento del passaggio di consegne.
Il Consiglio Pastorale resta il garante della continuità della cura di questa porzione del popolo di Dio, secondo l'indispensabile progetto pastorale. Ad esso può essere richiesta la verifica "dal basso" (per quanto odiosa sia questa espressione) del servizio reso (o non reso) dal ministro ordinato che lascia. Questa parola popolare si potrà affiancare ad una necessaria e limpida (manifestata) verifica "dall'alto" da richiedersi all'autorità gerarchica.
«Ne deriva la necessità di considerare il rapporto effettivo di un pastore con una comunità, come una delle condizioni essenziali che legittimano la sua posizione particolare nella chiesa. (...) Come la mancanza di comunione di un prete con il suo vescovo non invalida il sacramento, così la mancanza di comunione di un pastore con la sua comunità e la dissoluzione di fatto dei suoi rapporti pastorali non cancellano in lui il carattere ricevuto con l’imposizione delle mani. Però, come il primo titolo di legittimità condiziona la sua posizione nella chiesa, così anche il secondo la dovrebbe condizionare. Un pastore di chiesa non può essere imposto perennemente ad una comunità, anche se di fatto non vuole o non riesce a stare in essa come principio della sua comunione, semplicemente perché è stato validamente ordinato e perché di quel compito, che non attua, è stato legittimamente investito» (Severino Dianich, Teologia del ministero ordinato, 281).
Se la verifica evidenziasse gravi irregolarità dal punto di vista economico, il ministro ordinato dovrebbe essere chiamato a porre rimedio, prima di assumere un altro incarico; lo stesso dicasi se si evidenziassero gravi carenze dal punto di vista pastorale.
don Chisciotte Mc, 12.08.2020
- Dettagli

«Non è una foto stiracchiata con qualche programma.
Guarda che aerodinamica assume questo uccello nel volo... c'è da imparare!
Che cosa? A metterci tutto l'impegno possibile nel fare quel che si deve fare per andare dove si deve andare -e non parlo solo di luoghi fisici ma anche di luoghi da vivere.
Mi fa venire in mente una frase di Epitteto, il filosofo stoico dell'antichità, che dice più o meno così: "Innanzitutto dì a te stesso chi vuoi essere e poi fa ogni cosa di conseguenza"».
Massimo De Franceschi, FB 200811
«Io peccatore e vescovo mi confesso di sognare una Chiesa vestita solamente di vangelo e di sandali»
- Dettagli
 Casaldaliga, il vescovo poeta dell'Amazzonia
Casaldaliga, il vescovo poeta dell'Amazzonia
di Giorgio Bernardelli
«Alla fine del cammino mi diranno: hai vissuto? Hai amato? Ed io, senza dire niente, aprirò il cuore pieno di nomi». Tra le migliaia di versi scritti da dom Pedro Casaldaliga, forse è proprio questo il più adatto a riassumerne la figura alla notizia della scomparsa di questo vescovo-poeta degli ultimi nell'Amazzonia brasiliana. A 92 anni - già pesantemente indebolito dalla malattia - se ne è andato ieri il missionario claretiano spagnolo, vescovo emerito della prelatura di Sao Félix do Araguaia, che è stato uno dei volti più noti della teologia della liberazione. Catalano di nascita, in Brasile padre Casaldaliga ci era arrivato nel 1968 per andare a vivere tra i campesinos e i popoli indigeni di quest'area del Mato Grosso, già allora pesantemente minacciata. E quando tre anni dopo Paolo VI lo aveva chiamato a diventare il vescovo di questa regione immensa, si era fatto subito conoscere in tutto il mondo per la sua prima lettera pastorale dal titolo eloquente: Una Chiesa nell'Amazzonia in guerra contro il latifondo e l'emarginazione sociale.
Un impegno che avrebbe portato avanti instancabilmente per cinquant'anni, nonostante le ripetute minacce di morte, proseguite anche dopo che nel 2005 aveva lasciato per raggiunti limiti di età la guida della prelatura. Eppure per i poveri dell'America Latina Casaldaliga non è stato solo l'uomo della denuncia dell'ingiustizia. La sua grandezza è stata quella di aver dato forza ai loro sogni facendoli diventare verso poetico e preghiera. A partire dalla Messa della terra senza mali, da lui composta insieme all'altro poeta brasiliano Pedro Tierra alla fine degli anni Settanta. Un testo divenuto popolarissimo in quegli anni nel mondo missionario, ma anche occasione di scandalo per quella sua idea di riscrivere i testi liturgici a partire dalla vita, compresa quella dei popoli indigeni. Dom Pedro Casaldaliga la spiegava così: «Quando la sofferenza antica si trasforma in speranza, quando i figli degli oppressori si riconciliano con i discendenti delle vittime, quando il passato oscuro diviene promessa di avvenire, allora nasce come canto e liturgia la "terra senza mali", la visione che ha consolato lungo i secoli il pianto di un popolo condannato allo sterminio». In fondo in queste frasi c'è ciò che è stata tutta la vita di Casaldaliga: dare voce alle persone amate nel Mato Grosso ferito dall'avidità dell'uomo. «Io peccatore e vescovo mi confesso di sognare una Chiesa vestita solamente di vangelo e di sandali», recita un'altra delle sue frasi più note. Un sogno molto vicino a quello confidato da papa Francesco subito dopo la sua elezione. E non è un caso che anche un verso di dom Pedro compaia al numero 73 di Querida Amazonia, l'esortazione apostolica scritta a conclusione del Sinodo voluto proprio sulla regione del mondo a cui questo vescovo ha dedicato tutta la vita. Una terra che forse solo la parola dei poeti ci può davvero aiutare a salvare.
in "Avvenire " del 9 agosto 2020
- Dettagli
Abito di preti e consacrati: la dignità e l'efficacia
di Marco Tarquinio, 8 agosto 2020
Gentile direttore, in merito alla lettera pubblicata sabato 1 agosto 2020 sull’abbigliamento clericale, sono rimasto male della risposta che lei ha dato al lettore Salerno sull’abito che deve identificare il sacerdote. È come quelli che dicono che non è necessario venire in chiesa perché chi non ci viene potrebbe comportarsi nella vita in modo migliore! È vero che «l’abito non fa il monaco », ma rimane pur sempre vero che un buon monaco porta l’abito dignitoso per il suo stato. Se poi i laici chiedono ai sacerdoti di farsi riconoscere, vogliamo ancora dire che va bene tutto? Grazie.
don Stefano D’Atri, Duomo di Pietrasanta (Lu)
Gentile e molto reverendo don Stefano, mi spiace che la mia risposta l’abbia turbata, soprattutto perché sono ovviamente d’accordo con lei sulla dignità necessaria dell’abito sacerdotale. Anche per questo non penso e non ho scritto «che va bene tutto»... Ho scritto che conosco preti buoni e santi in talare (o in clergyman) e preti buoni e santi con la croce sulla giacca o un crocifisso al collo e perciò sono stato abituato a considerare prima di tutto i frutti della semina. Certo non ho scritto che mi piacciono i sacerdoti e i religiosi e le religiose indistinguibili per come vivono e agiscono, e per come vestono. Anzi no, mi correggo. Ne ho conosciuti, e ne sono rimasto conquistato, anche di non distinguibili a prima vista per il loro abito e però assolutamente straordinari. Sono preti e consacrati e consacrate che lavorano la vigna che è loro affidata in aree del mondo dove la Chiesa non è libera ed è anche perseguitata o rischia di essere fraintesa. Anche a loro penso, in positivo, quando rispolvero il vecchio detto «l’abito non fa il monaco».
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/abito-di-preti-e-consacrati-la-dignit-e-l-efficacia
- Dettagli
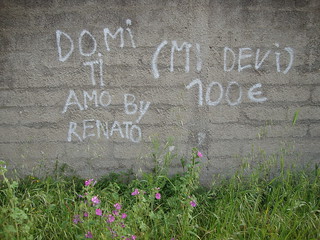 «In noi tutti, anche nei più disperati, c'è il desiderio di comunicare, di qualcuno che ci capisca e ci accetti. Questo stigma che portiamo dentro per sempre è un riflesso di Colui che ci ha creati e insieme testimonia le storture che noi abbiamo imposto a tale desiderio, a tale diritto sano.
«In noi tutti, anche nei più disperati, c'è il desiderio di comunicare, di qualcuno che ci capisca e ci accetti. Questo stigma che portiamo dentro per sempre è un riflesso di Colui che ci ha creati e insieme testimonia le storture che noi abbiamo imposto a tale desiderio, a tale diritto sano.
Il racconto della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli nel giorno di Pentecoste e della conseguente loro capacità di esprimersi e di farsi capire in tutte le lingue è una delle icone più efficaci del dono di comunicare che Dio elargisce.
Ma il dono della comunicazione può essere rifiutato e uno dei motivi che determina questo rifiuto è certamente quello della mancanza di fiducia nella gratuità e sincerità dell'atto comunicativo. Ancora una volta alla radice del rifiuto c'è l'avversario, il satana che aveva già inculcato il sospetto nel giardino dell'Eden, dicendo a Eva: "Ma è proprio vero che Dio vi abbia comandato di non mangiare da nessun albero del giardino?". La frase del tentatore, nella sua paradossalità, ha un sottinteso: "Ci sarà pure una ragione di convenienza personale per cui Dio vi ha proibito almeno uno dei frutti... Forse il suo agire non è disinteressato!"».
Carlo Maria Martini, " Ritrovare se stessi "
- Dettagli
 "Quando si cambia un prete" - 7
"Quando si cambia un prete" - 7
"Ministro" trae la sua radice etimologica dal latino "minus" e quindi significa "minore, servitore, servo". L'aggettivo "ordinato" (legato al sostantivo "ministro") richiama il latino "ordo", che identifica un gruppo, una classe... specie se finalizzati ad un incarico; quindi "ordinato" indica uno inserito in un gruppo per un incarico. In funzione di questo incarico, il ministro riceve una "ordinazione", cioè viene invocato su di lui lo Spirito Santo affinché sia inserito in un gruppo di servizio.
I ministri ordinati sono inseriti in un gruppo (non una casta) col preciso compito di servire il popolo di Dio (nel quale tutti sono sacerdoti, re e profeti, come Gesù).
E' evidente, quindi, che la perpetua o i familiari che abitano con un ministro ordinato non sono "la serva del prete"; è evidente che i consiglieri (del Consiglio Pastorale o del Consiglio Affari Economici) non sono lì a ratificare le decisioni del prete; è evidente che gli operatori pastorali (catechisti, educatori, allenatori, animatori liturgici....) non sono da considerarsi degli aiuti accessori alla azione del ministro ordinato.
Dunque, quando si cambia un ministro ordinato è perché sia meglio servito il santo popolo di Dio, il quale - nella sua santità di Corpo di Cristo - sarà anche in grado (ma dovrebbe essere una eccezione) di servire amabilmente anche quel figlio della Chiesa, ministro ordinato, che avesse dei problemi fisici, psicologici, relazionali, spirituali.
don Chisciotte Mc, 8.08.2020
- Dettagli
 Anche il mare nell'aldilà
Anche il mare nell'aldilà
di Enzo Bianchi
« (...) Sì, il mare m'incute anzitutto timore, per questo concordo con il giudizio della Bibbia: è un grembo del nulla, un abisso enigmatico, dal quale può sempre emergere il Leviatan, informe mostro marino. C'è un aspetto di ostilità del mare che non sono mai riuscito a negare o a dominare del tutto, forse perché non so nuotare bene o perché mi sento sicuro solo con i piedi a terra. Tuttavia amo il mare, al punto da desiderare la sua presenza anche nell'aldilà. Se ci saranno cieli nuovi e terra nuova, perché non anche un mare nuovo? Lo desidero a tal punto che, quando ho tradotto l'Apocalisse, mi sono sentito autorizzato a pensare che la promessa di Dio: "Il mare non ci sarà più!" significhi: "Il mare ostile non ci sarà più!". Se è vero che si va al mare soprattutto con il corpo, per fare il bagno, il mare cattura però molto di più il nostro intimo e diventa un oggetto sul quale i nostri occhi sostano, quasi a voler fissare quelle immagini così passeggere. Il mare non è mai uguale: pochi minuti dopo averlo guardato, appare diverso, perché la luce cambia, perché il suo movimento si ripete in modo differente.
Accanto ai colori, ecco i suoi movimenti, che a volte sembrano un gioco, quasi a rivelare la natura giocosa dell'universo: flusso e riflusso, inspirare ed espirare, con le onde più o meno bianche le quali non rompono il silenzio neppure con il loro muggire. Altre volte, soprattutto in inverno, il mare si scatena e si scaglia contro la terra, come se cercasse di vincerla.
Prima o poi giunge comunque la bonaccia e il mare diventa liscio come l'olio, l'orizzonte lontano si staglia netto, lasciando intravedere l'infinito. E così ritorno a contemplarlo, senza mai provare noia o stanchezza. Il mare sa raccontare il mio intimo più della terra o del cielo, perché conosce una grammatica dei sentimenti del mio cuore più precisa delle mie parole: la pace silenziosa che permette di abitare con sé nella sobria ebbrezza del vivere in salute e in relazioni di amore e di fraternità; l'ansia che a volte mi coglie in forma di turbamento serale; lo scatenarsi della protesta per il duro mestiere di vivere; l'impeto di sentimenti di guerra che occorre domare, tornando a guardare il mare».
in "laRepubblica" del 3 agosto 2020
- Dettagli
 "Quando si cambia un prete" - 6
"Quando si cambia un prete" - 6
Il cambio del luogo del servizio di un ministro ordinato richiede un considerevole dispendio di energie intellettuali, emotive, pastorali, economiche.
Si pensi all'analogia con il trasloco di una famiglia... solo che in questo caso le persone coinvolte sono molte di più!
Abbiamo già scritto di quanta cura dell'intelletto - mai senza lo Spirito Santo - i soggetti coinvolti debbano dedicare alla scelta, con tutti i suoi fattori.
E' più noto e sperimentato il movimento emotivo che questo evento porta con sé: dalle lettere di protesta alle raccolte di firme; dai pianti di chi lascia fino alle attese di chi accoglie; dai pettegolezzi fino alla fatica della elaborazione del lutto...
Lo scombussolamento pastorale è un "prezzo" che non viene mai conteggiato... ma in bilancio è una voragine! Spesso colui che sa di dover lasciare un luogo tira i remi in barca troppo tempo prima, oppure sospende ogni decisione, adducendo la ragione di non voler legare le mani al successore; colui che arriva - se è onesto - ammette di aver bisogno di uno-due anni prima di conoscere un po' la situazione; per non parlare delle relazioni pastorali più profonde, quelle relative alla conoscenza qualificata, al sacramento della riconciliazione, all'accompagnamento spirituale personale (di cui non parla più nessuno). Quanto "costa" tutto questo rallentamento, questo blocco?!
Infine vi è l'aspetto economico: ricerca e sistemazione delle case, traslochi, arredi, persone impegnate...
E così torniamo sempre al punto decisivo: in ordine all'obiettivo, la "spesa" (intesa a 360 gradi) è da ritenersi adeguata, necessaria, improrogabile? Sarà giudicata un investimento o uno spreco? Può essere meglio affrontata? Può essere dilazionata nel tempo (invece che così frequente, ultimamente)?
Anche in questo caso, confrontarsi con dinamiche analoghe presenti nelle famiglie aiuterebbe: una famiglia - con tutte le sue dinamiche - farebbe questa "spesa"?!
don Chisciotte Mc, 6.08.2020
- Dettagli
« (...) Ci chiediamo: in che modo possiamo *aiutare a guarire il nostro mondo, oggi*? Come discepoli del Signore Gesù, che è medico delle anime e dei corpi, siamo chiamati a continuare «la sua opera di guarigione e di salvezza» (CCC, 1421) in senso fisico, sociale e spirituale.
*La Chiesa, benché amministri la grazia risanante di Cristo mediante i Sacramenti, e benché provveda servizi sanitari negli angoli più remoti del pianeta, non è esperta nella prevenzione o nella cura della pandemia. E nemmeno dà indicazioni socio-politiche specifiche* (cfr S. Paolo VI, Lett. ap. Octogesima adveniens, 14 maggio 1971, 4). Questo è compito dei dirigenti politici e sociali. Tuttavia, nel corso dei secoli, e alla luce del Vangelo, la Chiesa ha sviluppato *alcuni principi sociali che sono fondamentali* (cfr Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 160-208), principi che possono aiutarci ad andare avanti, per preparare il futuro di cui abbiamo bisogno. Cito i principali, tra loro strettamente connessi: *il principio della dignità della persona, il principio del bene comune, il principio dell’opzione preferenziale per i poveri, il principio della destinazione universale dei beni, il principio della solidarietà, della sussidiarietà, il principio della cura per la nostra casa comune*. Questi principi aiutano i dirigenti, i responsabili della società a portare avanti la crescita e anche, come in questo caso di pandemia, la guarigione del tessuto personale e sociale. Tutti questi principi esprimono, in modi diversi, le virtù della fede, della speranza e dell’amore.
Nelle prossime settimane, vi invito ad *affrontare insieme le questioni pressanti che la pandemia ha messo in rilievo, soprattutto le malattie sociali. E lo faremo alla luce del Vangelo, delle virtù teologali e dei principi della dottrina sociale della Chiesa*. Esploreremo insieme come la nostra tradizione sociale cattolica può aiutare la famiglia umana a guarire questo mondo che soffre di gravi malattie. È mio desiderio *riflettere e lavorare tutti insieme, come seguaci di Gesù che guarisce, per costruire un mondo migliore*, pieno di speranza per le future generazioni (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 183)».
http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200805_udienza-generale.html
- Dettagli
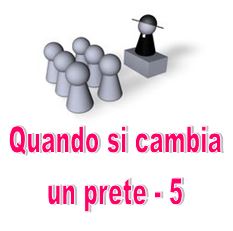 "Quando si cambia un prete" - 5
"Quando si cambia un prete" - 5
Quando si cambia un ministro ordinato, non lo si fa per fargli fare carriera e dargli "territori" sempre più grandi o "titoli" sempre più altisonanti.
E nemmeno per retrocederlo o confinarlo.
Prendiamo in prestito le parole di Paolo Rodari, su "La Repubblica" del 2 agosto 2020: «papa Francesco porta a Casa Santa Marta un nuovo segretario, don Fabio Salerno, 41 anni, calabrese, cresciuto nell'Accademia ecclesiastica di piazza Minerva, rione Pigna, cuore di Roma, dove si formano i diplomatici della Santa Sede. Salerno, infatti, ha esperienze diplomatiche in Nunziature e Missioni permanenti, come anche in Segreteria di Stato. Queste sue caratteristiche sono utili al Papa che come altro segretario ha scelto lo scorso gennaio il "prete di strada" uruguayano Gonzalo Aemilius. Così, a Santa Marta, Bergoglio unisce il profumo dei barrios sudamericani e l'esperienza della scuola diplomatica romana.
Aemilius prima, Salerno oggi, vanno a cambiare totalmente la squadra dei primi collaboratori del Pontefice: Alfred Xuareb prima, Fabiàn Pedacchio Leàniz e Yoannis Lahzi Gaid poi, infatti, dopo alcuni anni a fianco del vescovo di Roma sono tornati alle loro occupazioni precedenti. Si tratta di un mutamento notevole rispetto ai pontificati passati.
Un cambio nel nome della normalità. Francesco non si è portato dall'Argentina un suo segretario. Non ne aveva di esclusivi lì, non ne ha qui: i suoi collaboratori a Santa Marta lavorano part-time, uno di mattina, l'altro di pomeriggio, e con incarichi a tempo. La scadenza è un aiuto affinché gli incarichi siano vissuti nella sola ottica del servizio. Nessuno, oggi, può pensare di lavorare in curia per guadagnare posizioni di potere e di mantenerle a vita. Non è altro che «un normale avvicendamento di persone, disposto da Francesco per i collaboratori della curia romana», ha spiegato non a caso ieri il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando della nomina di Salerno.
Non è un mistero per nessuno che negli ultimi pontificati i segretari papali abbiano assunto un ruolo centrale. Stanislaw Dziwisz aveva accompagnato Wojtyla fino alla morte divenendo negli ultimi anni il suo braccio e la sua voce. Così Georg Ganswein è stato costretto a interpretare, prima e dopo la rinuncia di Ratzinger, un ruolo di filtro significante che l'ha esposto anche oltre i suoi stessi desiderata. Con incarichi a tempo, invece, tutto ciò tende a non accadere, la normalità inizia ad abitare nelle sacre stanze, a beneficio anzitutto dei diretti protagonisti. Difficile, per tornare al passato recente, che di qui in avanti un segretario papale al termine del pontificato divenga arcivescovo o addirittura cardinale per diritto acquisito».
don Chisciotte Mc, 4.08.2020
- Dettagli
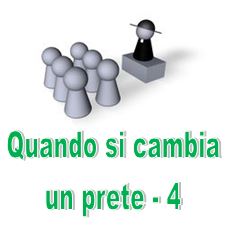 "Quando si cambia un prete" - 4
"Quando si cambia un prete" - 4
Nella oggettiva difficoltà di scegliere il titolo di questa serie di interventi, si è alla fine scelto l'espressione "si cambia un prete".
Ecco, dovrebbe cambiare un prete... non il volto di una comunità! E neppure la stretta cerchia degli impegnati!
Precisiamo: se è una comunità che ha bisogno di cambiamento (in base al discernimento di cui abbiamo parlato nei precedenti post di questa serie), occorrerà dichiarare che questo è l'obiettivo, condividerlo con tutti i soggetti coinvolti e porre le azioni (anche impegnative e dolorose) necessarie affinché venga raggiunto nei tempi e nei modi opportuni.
Ma se non è questo l'obiettivo, la comunità deve mantenere il suo volto, i suoi punti forti, le sue ricchezze (pur in una necessaria e mai conclusa dinamica); non deve subìre il trauma di un cambiamento imposto dallo stile originale di un ministro ordinato.
Come ci ha ricordato papa Francesco, la dimensione ecclesiale ha il primato su quella individuale, perché la comunione fraterna è il grembo entro cui nasce e si sviluppa la vita.
Il bene che fa bene a tutti - anche al ministro ordinato - è il popolo di Dio che procede il più possibile in termini sereni e progressivi, e non per sbalzi, sobbalzi, invenzioni del singolo, pur ordinato che sia.
E' semmai il ministro che si lascia plasmare dalla comunità (ovviamente negli aspetti virtuosi... che - chissà perché - emergono raramente nei racconti del neo-arrivato), è lui che cambia, che progredisce nel suo essere uomo, cristiano, ministro ordinato.
don Chisciotte Mc, 3.08.2020
- Dettagli
« (...) Occorre *discernere, scegliere e custodire l’essenziale* della fede cristiana. Dunque: togliere quello che abbiamo confuso come prioritario e necessario ma che non lo era. (...)
Un mondo finisce e qualcos’altro nasce, grazie alla *novità del Vangelo*. Abbandonare vecchi schemi e strutture e inventarne di nuove. Ma questo tempo inaugurale, aurorale, richiede *coraggio e creatività*, il coraggio di abbandonare vecchi schemi e vecchie strutture e inventarne di nuove. “L’Evangelo – scrive Bellet – ““può apparire come evangelo, cioè la parola, appunto, inaugurale che *apre lo spazio di vita*?. (...)
È tempo, dunque, di grande immaginazione. Perché non è il Vangelo a essere messo in scacco ma, piuttosto, la modalità con la quale noi cristiani fino ad ora lo abbiamo vissuto e comunicato. *Non è la fine della fede ma di una certa fede*.
E forse, anche se oggi a noi non lo pare, è una fortuna. Ecco perché siamo chiamati a discernere tra sostanza e forma, tra consuetudini e verità, come un pellegrino che deve compiere un lungo cammino e che deve mettere nella sua bisaccia tutte e solo le poche cose essenziali. *La Parola, la cura liturgica, la formazione, la costruzione di una chiesa di popolo*. Se i preti investissero tempo, studio, energie e risorse in queste priorità avremmo una Chiesa diversa. Se i laici imparassero a custodire la passione per il Vangelo, a prescindere dalle paure o dalle pigrizie dei loro preti, cammineremmo con altro passo. (...)
Stiamo velocemente camminando verso una nuova forma di cristianesimo. *Un cristianesimo per scelta e dunque un cristianesimo di minoranza*. Dove si giungerà alla fede per conversione e per convinzione. Piccole comunità fondate più sulle relazioni che sulle strutture, in una pastorale più di proposta che di conservazione. Non spaventate di essere una “parte”, neanche la più consistente, del “tutto”, in una società sempre più “plurale”, segnata sia dalla crescita esponenziale degli “indifferenti”, sia dal timido ma costante affacciarsi nei nostri territori dei “differenti”, uomini e donne che credono in un Dio diverso dal Dio di Gesù Cristo. Una Chiesa, quella di domani, che papa Francesco continua a delineare come una Chiesa fedele allo “stile” di Gesù. (...)
Vedo attorno, soprattutto tra i preti e gli operatori pastorali, molta fatica e scoraggiamento. Non è forse venuto il tempo di *un Sinodo* diocesano per un *confronto comunitario* attorno a questo improrogabile “nuovo inizio”?».
Daniele Rocchetti, 30 Luglio 2020
- Dettagli
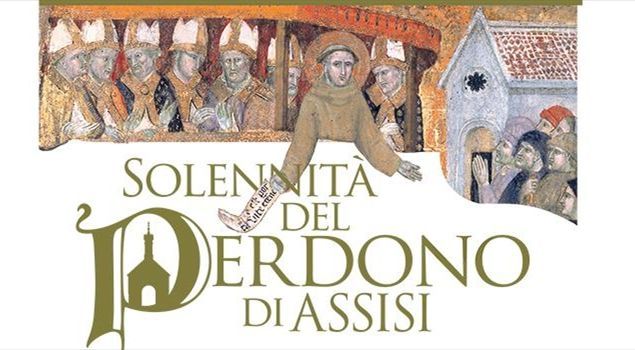 Le *condizioni per ricevere una indulgenza* non sono degli atti magici eseguiti i quali "automaticamente" avviene ciò che è desiderato; tanto meno sono gesti che "obbligano" Dio Padre a concedere il perdono. Se fossero pensati o vissuti così... ovviamente allontanerebbero dal vero volto di Dio Trinità e otterrebbero l'effetto contrario a quello desiderato!
Le *condizioni per ricevere una indulgenza* non sono degli atti magici eseguiti i quali "automaticamente" avviene ciò che è desiderato; tanto meno sono gesti che "obbligano" Dio Padre a concedere il perdono. Se fossero pensati o vissuti così... ovviamente allontanerebbero dal vero volto di Dio Trinità e otterrebbero l'effetto contrario a quello desiderato!- Dettagli
Doni sorprendenti della creatività di Dio, che fa nuove anche le fioriture delle piante grasse!




