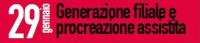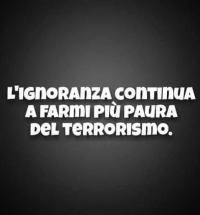- Dettagli
 «Se dovessi raccontare la storia della famiglia di origine della mia nonna ne verrebbe fuori che la famiglia del mulino bianco che tanti vorrebbero non è mai esistita. Questa storia penso che sia comune a tutte le famiglie. 14 fratelli composta da grandi santi e da grandi peccatori. Grandi litigi e grandi riconciliazioni. Eventi tragici: malattie impietose che hanno portato via da un giorno all'altro fratellini e sorelline, la guerra, l'orrore del nazismo che ha ucciso barbaramente un nipote e un fratello prete. Ma anche l'insperato e assurdo benessere portato dalla spagnola, mio bisnonno era falegname e aveva avuto un picco di lavoro costruendo bare. Strani casi di utero in affitto: mia bisnonna aveva "regalato" una delle sue figlie a sua sorella sterile portandosela con sé in Sudamerica. Separazioni, di cui il fratello che l'ha subita costretto a fuggire e rifarsi una vita in America, la cognata colpevole, una volta che ha perso il compagno ritornata e accolta in famiglia dai cognati come una sorella. Una sorella suora, morta consunta, ma che non ha lasciato fino all'ultimo i bambini di cui si occupava. Cugine ricchissime che negli anni 50 facevano concorrenza a Sophia Loren, per poi morire sole. Insomma di tutto e di più già era all'ordine del giorno nel secolo scorso: e oggi vogliamo la famiglia del mulino bianco che non esiste?».
«Se dovessi raccontare la storia della famiglia di origine della mia nonna ne verrebbe fuori che la famiglia del mulino bianco che tanti vorrebbero non è mai esistita. Questa storia penso che sia comune a tutte le famiglie. 14 fratelli composta da grandi santi e da grandi peccatori. Grandi litigi e grandi riconciliazioni. Eventi tragici: malattie impietose che hanno portato via da un giorno all'altro fratellini e sorelline, la guerra, l'orrore del nazismo che ha ucciso barbaramente un nipote e un fratello prete. Ma anche l'insperato e assurdo benessere portato dalla spagnola, mio bisnonno era falegname e aveva avuto un picco di lavoro costruendo bare. Strani casi di utero in affitto: mia bisnonna aveva "regalato" una delle sue figlie a sua sorella sterile portandosela con sé in Sudamerica. Separazioni, di cui il fratello che l'ha subita costretto a fuggire e rifarsi una vita in America, la cognata colpevole, una volta che ha perso il compagno ritornata e accolta in famiglia dai cognati come una sorella. Una sorella suora, morta consunta, ma che non ha lasciato fino all'ultimo i bambini di cui si occupava. Cugine ricchissime che negli anni 50 facevano concorrenza a Sophia Loren, per poi morire sole. Insomma di tutto e di più già era all'ordine del giorno nel secolo scorso: e oggi vogliamo la famiglia del mulino bianco che non esiste?».- Dettagli
 Il giubileo della misericordia e l’ossessione della piazza
Il giubileo della misericordia e l’ossessione della piazza- Dettagli
 Ancora a proposito della copertura delle statue.
Ancora a proposito della copertura delle statue.- Dettagli
«Condivido volentieri questo articolo di Paolo Tassinari, che esprime molto bene sia le ragioni di criticità circa alcuni aspetti del ddl sulle unioni civili, sia i motivi di perplessità relativi alla manifestazione del Family Day.
Aggiungo un'osservazione "storica": la prima edizione del Family Day nel 2007 contribuì a far cadere il governo Prodi, colpevole di aver presentato una proposta di regolamentazione delle unioni civili nella forma molto moderata del DICO, che non sfiorava neppure da lontano l'aspetto della adozione per le coppie omosessuali.
Da allora molte cose sono cambiate; la manifestazione di sabato - per quanto possa essere imponente - non scalfira' neppure la tenuta dell'attuale governo.
Tuttavia una lezione dovrebbe essere tratta: la posizione massimalista assunta all'epoca dai vertici della Chiesa cattolica ha ottenuto soltanto di posticipare il problema, creando le condizioni per la stesura di un disegno di legge che è senza dubbio più avanzato sul fronte della omo-genitorialita'.
Insomma, chi troppo vuole, nulla stringe: chiunque sceglie la strategia di mostrare i muscoli, si espone sempre al rischio di incontrare prima o poi un avversario più corpulento che lo mette al tappeto.
A mio avviso, lo stile della Croce - lo stile della misericordia - dovrebbe suggerire l'opportunità per la comunità ecclesiale di prendere le distanze da qualunque tentazione di cedere alla volontà di potenza, sia pure a fin di bene. Come scrive il
- Dettagli
Credo che l’introduzione nel linguaggio politico contemporaneo dell’espressione «multikulti» si debba alla cancelliera tedesca Angela Merkel. «Multikulti» è un concetto che nasce dalla sovrapposizione di due diversi fenomeni con status molto differenti tra loro. Il primo è la multiculturalità. Oggi viviamo in società multi-culturali, dove melting pot e coesione non si realizzano più. Ci troviamo di fronte a una situazione per cui, di fatto, in ogni città europea vi è una compresenza di persone che hanno
- Dettagli
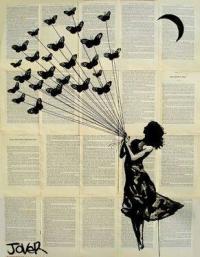 Il linguaggio dell'amore
Il linguaggio dell'amore - Dettagli
Guarda qui le foto: http://ilcassetto.forumcommunity.net/?t=48631142
- Dettagli
 Il rancore e il perdono dietro le sbarre
Il rancore e il perdono dietro le sbarre «Molti di loro vogliono chiedere scusa, ma purtroppo nella maggior parte dei casi le loro scuse non vengono accettate, perché anche quello del perdono è un cammino difficile. E in questi ragazzi respinti la speranza di riparare resta irrisolta».
- Dettagli
 Rapporto OXFAM
Rapporto OXFAM- Dettagli

«Chi ha guardato negli occhi la Bellezza
- Dettagli
 Sesso e gender senza pregiudizi
Sesso e gender senza pregiudizi - Dettagli
 Palestre di vita
Palestre di vita- Dettagli
 Quello che Bertone non capisce
Quello che Bertone non capisce- Dettagli
 I riti delle feste: la molla invisibile che trascina le nostre vite
I riti delle feste: la molla invisibile che trascina le nostre vite Che forza è? Un grande libro, pubblicato alcuni anni or sono e scritto da uno dei maggiori antropologi del secolo scorso, Roy Rappaport, è interamente dedicato all’origine antica dei riti. Rappaport ha passato la vita a studiare i riti, a cercare di rintracciarne la storia e il senso. I riti, se ci pensate, sono qualcosa che sembra strano e poco comprensibile agli occhi di una modernità ingenua. Un rito è un gesto, un’azione, una parola, che vengono ripetuti eguali, più o meno regolarmente, e che hanno un’intensa portata emotiva per chi li compie, anche se spesso non sembrano avere utilità diretta, o almeno non un’utilità capace di giustificare la straordinaria forza con cui permangono. Perché da millenni ci scambiamo un regalo alla fine di dicembre? Sono crollati imperi, sono stati trucidati interi popoli, abbiamo cambiato religione più volte, siamo stati ricchi e poveri, dominati e dominatori, abbiamo creduto nelle streghe e siamo arrivati sulla luna, e con assoluta regolarità ad ogni fine dicembre ci siamo scambiati un piccolo regalo, abbiamo acceso una candela o una piccola luce. Non è straordinario?
- Dettagli
Che meraviglia questo video: chiaro, diretto e teologicamente impeccabile.
Nessun papa si era mai spinto a dichiarare così chiaramente le cose!
Adesso si attira le ire degli integralisti di tutte le fedi.
Ma io qui continuo a trovare il vero gusto del vangelo!
don Chisciotte Mc
- Dettagli
 «Ogni giorno c'era una nuova parte di lei che mi si mostrava. Era come se non l'avessi mai conosciuta del tutto. Come le pareti di roccia di una montagna che lentamente si mostrano al virare del sole durante il giorno, ma se cominci a scalarla, scoprirai che nulla era come appariva dal basso, che fosse giorno o notte piena.
«Ogni giorno c'era una nuova parte di lei che mi si mostrava. Era come se non l'avessi mai conosciuta del tutto. Come le pareti di roccia di una montagna che lentamente si mostrano al virare del sole durante il giorno, ma se cominci a scalarla, scoprirai che nulla era come appariva dal basso, che fosse giorno o notte piena.- Dettagli
Mentre ringrazio tutti i pellegrini
(in particolare coloro che hanno fornito le foto da pubblicare),
avviso i naviganti che sono state risistemate le foto pubblicate,
in modo che - cliccando sulla immagine-
essa si apra nel formato originale.
- Dettagli
Una esperienza di condivisione di vita
fra popoli e religioni diverse:
http://wasns.org/-oasi-di-pace-