- Dettagli
- Dettagli
- Dettagli
di mons.Tonino Bello
Solo se avremo servito potremo parlare e saremo creduti.
Solo allora potremo riprendere le vesti sontuose del nostro prestigio sacerdotale
e nessuno avrà nulla da dire.
- Dettagli
- Dettagli
Si siedono davanti all'altare e ai fedeli spiegano i trucchi per evitare di essere raggirati. E' un progetto concordato tra il questore e il vescovo. I "ladri di anziani" non sono violenti, ma, commenta don Giorgio «umiliano le vittime che di colpo sentono il peso della loro età e della solitudine»
di Wanda Valli
Sono arrivati in chiesa, nella parrocchia di San Paolo Apostolo alla Spezia, infreddoliti per il freddo e la pioggia battente. Ma decisi a farsi aiutare. E lì, due passi sotto l'altare, hanno trovato gli agenti della Squadra anticrimine della Questura. E proprio loro, gli agenti, hanno cercato di spiegare alle vittime come si evitano i "ladri di anziani". Prima di tutto come si riconoscono. Grazie a un video della Questura, girato con attori professionisti, gli anziani hanno visto all'opera truffatori e complici, hanno ascoltato consigli e suggerimenti. L'idea è partita dal questore della Spezia, Gaetano D 'Amato che ha accolto l'invito del vescovo, monsignor Francesco Moraglia. (...)
Ma come operano i "ladri di anziani"? Intanto sono insospettabili, nei modi e nel modo di presentarsi, sempre gentili, educati, ben vestiti. E allora attenzione a chi si presenta a casa spacciandosi come agente della società che eroga il gas, oppure come falso ispettore dell'Inps che va a domicilio a restituire soldi di una pensione. Quando escono da casa mancherà sicuramente qualcosa. Per strada, poi, le truffe spesso hanno due protagonisti. Il primo ferma l'anziano e gli spiega che ha bisogno di soldi, che è disposto in cambio di poche decine di euro a dare in cambio un orologio di famiglia. E se chi ha di fronte ha qualche dubbio e si guarda in giro, ecco spuntare un'altra persona, uomo o donna che sia, a fare da garante, a dire che sì, l'orologio è davvero bello e prezioso. Chi si fida e paga si ritroverà invece con una patacca. Le truffe accadono spesso in luoghi insospettabili, nelle chiese, nei cimiteri. Qui può esserci chi si offre di proteggere l'anziano o l'anziana vittima con un ombrello per poi rubargli il portafogli. I "ladri di anziani" non sono violenti, ma, commenta don Giorgio «umiliano le vittime che di colpo sentono il peso della loro età e della solitudine».
- Dettagli
di Enzo Bianchi
Nella sua predicazione Gesù è ricorso a racconti e narrazioni: le parabole, frutto della sua ricerca della volontà di Dio, della sua immaginazione, della sua osservazione contemplativa del cuore umano, della natura e delle storie personali e collettive. Ma tra queste, ve n'è una che appare come «incompiuta», una parabola che sembra attendere altri eventi, quasi una parabola in atto di compiersi: è quella dei due figli, che abbiamo memorizzato come «la parabola del figliol prodigo». Una parabola con il finale sospeso: il figlio perduto ritorna a casa, il padre lo abbraccia e gli usa piena misericordia senza chiedergli conto del male commesso, l'inizio della festa per questo figlio ritrovato... Poi ecco apparire l'altro figlio, il maggiore, rimasto sempre a casa: risentito, non vuole partecipare alla gioia del padre e del fratello. Allora il padre esce di casa anche per lui, pregandolo di entrare e unirsi alla festa... La fine del racconto tace sulla reazione del figlio maggiore: è rimasto ostinatamente fuori? Cos'è successo dopo l'avvio della festa con la musica e il pranzo preparato? Una parabola incompiuta, appunto. Suonerebbe poco riverente verso il Vangelo osare immaginare non un'altra fine, ma un seguito che renda la parabola compiuta? Significherebbe forse indicare un esito, far accadere ciò che non è stato narrato come accaduto... Ma siccome tutte le volte che leggo questa parabola penso sempre all'esito che avrebbe potuto avere e mi ritrovo a ipotizzare sempre lo stesso finale, oso affidarlo ai lettori, certo della loro capacità di farne buon uso e di non confonderlo con il Vangelo stesso. Il figlio minore scappato di casa, dopo aver dilapidato tutta l'eredità pretesa dal padre, si era deciso a ritornare a casa... (...) Festa grande, festa per tutti! Ma l'altro figlio dov'è? A quest'ora avrebbe dovuto essere rientrato dai campi... Dov'è? Il padre esce di nuovo, di corsa, per cercarlo e dargli la buona notizia del fratello tornato, non più perduto come un morto, ma vivo! Invece, il dramma: nell'ora in cui il padre ha riacquistato un figlio rischia di perdere l'altro. Non appena il maggiore, infatti, vede il padre e sente la sua «buona notizia», ecco l'indignazione, la rivolta! La sua voce risuona dura, tagliente: «Come puoi chiedermi di essere contento e di far festa per questo tuo figlio che ha preso i suoi soldi prima che gli spettassero, che è andato a spenderli comprandosi amici interessati e amore di prostitute, che ha lasciato a noi la fatica e il lavoro, senza mai dare un cenno di vita? E io dovrei far festa?». Ma il padre: «È mio figlio, certo, ma è anche tuo fratello! Io sono il padre di tutti e due: vi ho amati e vi amo, siete la mia vita! Tu sei rimasto qui accanto a me, è vero, lui se n'è andato lontano, ma io vi amo tutti e due, di tutti e due mi sento padre e non posso fare diversamente. Se non vi sentite fratelli tra voi, è come se io non potessi essere vostro padre!». Come aveva abbracciato il figlio fuggito, il padre ora supplicava l'altro figlio che non voleva partecipare alla festa. Come aveva atteso il figlio perduto, ora era disposto ad aspettare che il primogenito entrasse in casa per la festa. Fino a quando restò là a pregarlo? Fino al momento
- Dettagli
 Questa notte ha nevicato, ma non molto...
Questa notte ha nevicato, ma non molto...
Salutiamo la neve!
Chi non avesse ancora visto il nostro album fotografico su una delle nevicate dell'anno scorso, può trovare qui le foto!
- Dettagli
In catene nel deserto, l'odissea libica dei 255 eritrei
Prigionieri nel Sinai, in catene come schiavi, ostaggio dei trafficanti egiziani. Così è finita una parte consistente, ben 80 dei 255 eritrei che nel luglio scorso avevano rischiato di morire nella famigerata prigione libica di Al Braq, in pieno Sahara, dopo essere stati respinti in mare dall'Italia e poi liberati grazie alla pressione delle organizzazioni umanitarie sul nostro governo. Un mese fa alcuni di loro sono fuggiti dalle sabbie libiche alla volta di Israele, su una delle nuove rotte della disperazione verso l'Europa, che ora incrociano il Medio Oriente e la Turchia, a rischiare di morire in un altro deserto.
L'allarme è stato lanciato ieri, esattamente come l'estate scorsa, dal blog dell'agenzia di cooperazione allo sviluppo Habeshia. Secondo la quale ci sono 600 persone in condizioni disperate da oltre un mese nel deserto al confine tra Egitto e Israele, prigioniere del racket. Oltre agli 80 eritrei fuggiti da Tripoli, somali e sudanesi. Tra questi, vi sono anche donne, segnala il blog curato da Roma dal sacerdote cattolico eritreo Mosè Zerai. Ciascuno ha versato al racket 2.000 dollari. Ma i trafficanti ne pretendono altri 8.000.
«Gli eritrei
- Dettagli
- Dettagli
- Dettagli
"C'è qualcosa di sacro nelle lacrime, non sono un segno di debolezza, ma di potere.
Sono messaggeri di dolore travolgente e di amore indescrivibile".
- Dettagli
Non c'è affatto bisogno di compiere questi tagli, anche perché ci portano fuori dalla verità.
La Chiesa rimane la Chiesa e Dio rimane Dio. Chi sarei io fuori dal Popolo di Dio e quale forza mi rimane se la fede nell'Altissimo è venuta meno?
La Chiesa non mi nega di vivere autenticamente il Vangelo ed il mio impegno con Dio mi è proprio necessario ora che mi sono deciso a fare qualcosa sul serio.
Lo so che nel passato troppe volte la religione era sinonimo di "non facciamo storie, state buoni; non facciamo scioperi, restiamo sul sicuro" ma so anche che le cose sono cambiate e che la parola di Dio ha cominciato a contestarci e interrogarci sulla giustizia e sull'amore più che sulle processioni e la grandiosità della chiese da costruire.
Perché abbandonare la Chiesa proprio nel momento in cui mi sento più Chiesa? Perché abbandonare l'ispirazione di Dio proprio quando ne abbiamo più bisogno? Perché pensare che Lui ci contrasti proprio mentre ci avviciniamo con più impegno all'uomo? Non è Dio dalla parte dell'uomo? Non è Lui che ne prende le difese? Leggete il Vangelo di Matteo e ditemi se potete trovare parole più dure di quelle del capitolo 25 in difesa della giustizia e della liberazione dell'uomo.
- Dettagli
di Massimo Gramellini
Se il signor Maro Carfagna, barbuto ministro della Campania, avesse minacciato le dimissioni, affermando che nel suo partito gli impediscono di battersi per la legalità, ora saremmo qui a discutere coi sopraccigli arcuati di malapolitica e affaristi (cosa diversa dagli uomini d'affari). Ma poiché Maro si chiama Mara e ha il corpo e gli occhioni che sapete, la sua denuncia è già stata declassata a scatto isterico, baruffa fra comari. Invece che gli appalti del termovalorizzatore di Salerno, a tener banco sono i suoi rapporti umani: con l'amico Bocchino e la nemica Mussolini. L'algida ministra ci ha messo del suo, paragonando la collega a una popolana sguaiata. Ma non c'è dubbio che il circo mediatico e l'interesse dei lettori hanno sterzato subito verso il gossip, sottovalutando la sostanza delle sue parole.
E' un problema con cui tante donne meno fortunate della Carfagna devono fare i conti ogni giorno negli ambienti di lavoro. Il parere femminile vale meno e non è considerato autorevole. Quando un uomo s'arrabbia, ha carattere. Quando si arrabbia una donna, ha le mestruazioni. Oppure non le ha più. Non basta nemmeno maschilizzarsi dentro tailleur assertivi e posture manageriali. Se sei bella, i maschi ti desiderano ma non ti considerano: e tutti pensano (anche le donne) che la tua carriera non sia merito dei talenti, ma degli amanti. Se poi sei soltanto passabile, ti trattano come una crocerossina, un angelo custode, una bestia da soma: comunque una comparsa nel film del loro successo professionale, intitolato «Impari Opportunità».
- Dettagli
- Dettagli
La cosa più bella? Chi tu ami, l'oggetto del tuo amore. Bellissimo è l'amato, ripete il Cantico dei Cantici. L'amore veste di bellezza e la bellezza a sua volta genera desiderio. In una sorta di circolarità ininterrotta.
- Dettagli
- Dettagli
di Joseph Ratzinger
Ci sono dei segni che ci spaventano e che inquietano. Però ci sono anche altri segni che ci danno speranza. Abbiamo parlato in abbondanza delle minacce e degli scenari di terrore. Aggiungerei solo un elemento, che traggo dalle visite dei vescovi e che mi brucia dentro. Tanti vescovi, soprattutto dell'America Latina, mi dicono che là dove passa la strada della coltivazione e del commercio della droga
- Dettagli
di Philippe Clanché
Il tema “assemblee domenicali” figurava all'ordine del giorno dei vescovi francesi riuniti a Lourdes dal 4 al 9 novembre per il loro incontro annuale. Si trattava di vedere “come santificare oggi la domenica, giorno del Signore”, spiegava, prima dell'appuntamento pirenaico, il vescovo di Valenza Jean-Christophe Lagleize, che ha presieduto la commissione preparatoria. Per i nostri vescovi, l'equazione è semplice: assemblea domenicale uguale celebrazione eucaristica. (...) Può stupire l'assenza di proposte alternative per celebrare questo giorno particolare, sia nella società che per i credenti. Autore di un'opera importante sull'argomento, Le dimanche en déroute, padre François Wernert è stato consultato dalla commissione preparatoria. “La domenica vissuta e proposta attualmente dalla Chiesa cattolica è ormai molto fragile, spiega. E questa situazione non è imputabile unicamente alla secolarizzazione”. Per il ricercatore in teologia pratica e teologia pastorale alla Facoltà di teologia cattolica di Strasburgo, la Chiesa francese ha perso due occasioni per ripensare in modo diverso l'appuntamento del Giorno del Signore. “Nel 1990, riuniti a Lourdes, i vescovi non hanno valutato correttamente la pratica delle Assemblee domenicali in assenza di preti (Adap), molto diffuse tra il 1970 e il 1990. Hanno subìto la pressione di un documento romano del 1998 (Direttorio) che inquadrava le Adap senza incoraggiarle. L'episcopato francese avrebbe potuto mantenere la sua linea.” Risultato: la soluzione “solo eucarestia” è diventata la regola, con un modello dominante rafforzato dalla ristrutturazione delle parrocchie. In effetti, ogni domenica, viene assicurata una messa ad orario fisso nella chiesa del paese più importante, e nei paesi vicini si fa quello che si può. “I vescovi hanno pensato che tutti si sarebbero spostati per questa messa centrale, dice François Wernert. Hanno sottovalutato le resistenze della maggioranza, e le difficoltà per le persone anziane e i bambini. Le piccole entità si sono ritrovate più fragili”. Il teologo preconizza di rivedere quella scelta. “Bisogna evitare la dialettica tra la soluzione 'solo eucarestia” e il niente. Questa cosa non ha futuro. Ritroviamo l'importanza dell'assemblea cristiana di prossimità ecclesiale. Proponendo solo l'eucarestia, si escludono altre forme di assemblea. Parlando di incontri di prossimità ovunque, la proposta diventa inclusiva e richiama l'eucarestia nel giorno in cui è possibile”. E ricorda che nelle Chiese dell'Africa e dell'America latina, dove i preti sono pochi, i fedeli si riuniscono comunque alla domenica. Un altro consiglio offerto dal teologo alsaziano: immaginare la domenica con altri gruppi. “Ovunque, nella società, questo giorno è associato a valori positivi: attività, vita associativa, attenzione agli altri. La Chiesa cattolica oggi deve dialogare e trovare una relazione di reciprocità con la società per vivere la domenica”. E quindi tentare la riconciliazione tra gli ex rivali della piazza del paese, oggi altrettanto spenti: il bar e la chiesa. Staremo a vedere se i nostri vescovi, che non hanno manifestato un rifiuto nei confronti della diagnosi di padre Wernert, accetteranno di far evolvere la loro visione del Giorno del Signore. Con il confratello padre Marcel Metzger, François Wernert ha appena pubblicato una guida pratica intitolata Célébrations dominicales de la Parole. Recueil de l'Assemblée (ed. du Signe). Nella prefazione, l'arcivescovo di Strasburgo Jean-Pierre Grallet, scrive: “Molti motivi ci incitano a combinare l'invito a riunirci tutti insieme
- Dettagli
L'umorismo, al contrario, è una manifestazione della generosità: sorridere di ciò che si ama è amarlo doppiamente.
- Dettagli
di Giulio Iacchetti
Non ricordo con precisione il mio primo incontro con don Milani; nella fase che ha preceduto il servizio militare mi è capitato di approfondire il discorso sull'obiezione di coscienza e credo di averlo incontrato a quell'epoca, leggendo un volumetto postumo, L'obbedienza non è più una virtù, scritto da don Milani insieme ai suoi alunni della scuola popolare di Barbiana. Confrontandomi con quei contenuti ho scelto poi di farlo, il servizio militare, perché ritenevo di non essere ispirato da passioni sincere per fare obiezione di coscienza. Forse mi mancavano argomenti sufficienti per sostenere una scelta che a quell'epoca era molto rigorosa. Un giorno, all'inizio degli anni Novanta, di ritorno da Roma, in un viaggio assieme ad alcuni amici, abbiamo deciso di uscire all'uscita Mugello e di salire a Barbiana: è stato un momento molto forte dopo il quale ho iniziato a leggere e a informarmi maggiormente sull'argomento. Poi ho incrociato Lettere ad una professoressa. Quando mi chiedono che libro voglio ricordare sopra ogni altro io non ho nessun dubbio, cito sempre Lettere ad una professoressa; per me è ancora uno stimolo fortissimo. Leggendolo, capisco che la sostanza diventa vita e le teorie diventano sangue e carne; mi ritrovo ogni volta commosso dall'esperienza di vita di una persona e di questi ragazzini che, insieme, scrivono un testo capace di azzerare ogni certezza e ogni precisa posizione, e così facendo riescono a costruire un'idea fatta di vissuto e di esistenza autentica, che porta dritti all'essenza del ruolo dell'insegnante e della formazione, visti come possibilità di riscatto dei più poveri. La dedizione totale alla propria missione è, a mio avviso, una testimonianza spendibile da ognuno di noi, a prescindere dalla questione religiosa, che mi interessa relativamente. In qualità di progettista mi capita spesso di coprire il ruolo del docente, sebbene non sia per me una cosa continuativa; ogni anno ho un corso d'esame e capitano altri lavori presso il Politecnico o altre strutture universitarie. In queste situazioni la mia tensione è quella di trattare le persone con lo sguardo che potrebbe avere don Milani. Trovo che sia molto semplice stigmatizzare il difetto, il problema, la mancanza, l'incapacità, l'insufficienza, ma è più ardimentoso e più appassionante cogliere il buono da ogni idea, anche se mal espressa. Questa è la sfida di sempre: credo che nessuno di noi abbia diritto di bocciare e di rimandare gli alunni, come non aveva diritto la professoressa del libro. All'epoca c'era una scuola classista, nella quale per i figli dei poveri o per chi abitava in montagna era preclusa ogni possibilità di proseguire gli studi; don Milani lo spiega molto chiaramente, dati alla mano, in termini di giornate scolastiche perse da coloro che non avevano accesso. Gli scolari si perdevano, non andavano più a scuola e interrompevano in anticipo gli studi, spesso venivano bollati come inadatti allo studio, respinti e rimandati nelle fabbriche e nei campi. Adesso, forse, la situazione del diritto allo studio, grazie anche all'azione di don Milani, è cambiata; purtroppo è cambiata in peggio anche la qualità della scuola italiana. Le sue passioni avevano a che fare con situazioni molto concrete, dall'organizzazione della scuola popolare, dove quelli più grandi insegnavano a quelli più piccoli, al suo odio verso la ricreazione, vissuta come una forma di impegno che portasse a dimenticarsi il dovere della formazione e per poter affrontare bene il mondo. Aveva anche scritto a un regista francese per proporgli la trama di un film su Gesù Cristo, per dimostrare che la vita di Gesù Cristo era simile alla vita degli operai; non era solo una questione di fatti evangelici e sacri ma una vita di tristezza e restrizione. Sosteneva che i poveri, i suoi contadini e operai, andando al cinema potevano uscire con l'idea che Gesù Cristo aveva a che fare con la loro vita. Aveva scritto a Bernabei, allora presidente della Rai, per chiedere che in televisione fossero insegnate le lingue straniere, perché diceva che i figli degli immigrati che tornavano in Italia non sapevano governare bene la lingua che avevano imparato e voleva che fosse forma di riscatto anche l'insegnamento della lingua inglese o tedesca. Salendo sulla montagna che porta a Barbiana all'inizio si è molto baldanzosi, la strada è bella, in mezzo ai cipressi; poi c'è un ultimo tratto da fare a piedi. Di recente mi è capitato di arrivarci all'ora del crepuscolo, cominciava a fare freddo e quella tipica energia da gita in montagna, allegra, si era smarrita, lasciando il posto a una desolazione completa. Si vedono la canonica e il piccolo cimitero in cui è sepolto. Così ci si può ricondurre veramente allo spirito della sua lezione, alla volontà di mantenere tutto inalterato. Il suo allievo prediletto, che lui ha accolto come un figlio, Michele Gesuardi, in seguito diventato presidente della provincia di Firenze, ha voluto mantenere Barbiana inalterata; per fortuna don Milani non è diventato un'icona nel mondo della chiesa cattolica, ma è rimasto una figura scomoda, scomoda per tutti. A Barbiana non ci sono chioschi che vendono bibite, non c'è la santificazione che si percepisce quando si va in pellegrinaggio a Pietrelcina. Ancora oggi è un paese difficile da raggiungere, proprio come il suo ispiratore. Visitando la terra in cui ha vissuto e operato, e naturalmente leggendo i suoi libri, si producono sempre dei dubbi. Don Milani, per me, resta un meraviglioso generatore di dubbi.
- Dettagli
- Dettagli
di Vittorio Cristelli
Si susseguono a ritmo battente le notizie, regolarmente riportate da questo settimanale, dell'affido ad un solo prete di tre, quattro, addirittura sette parrocchie. E' il segno evidente della scarsità di clero e delle vocazioni al sacerdozio. Ma non è di questo che voglio parlare. Dietro queste notizie c'è un uomo, di Dio fin che volete, ma con le sue forze, la sua salute, le sue capacità. Che possono anche venir meno. E può essere quindi a disagio. A questo disagio dei preti è stato dedicato uno studio della rivista "Il Regno", che riporta analisi e inchieste fatte da Alessandro Castegnero, presidente dell'Osservatorio socio-religioso del Triveneto e riguardano quindi anche le diocesi di Trento e di Bolzano. Possiamo quindi sentirvi le voci, i lamenti, le confidenze e i sospiri dei nostri preti. Vi si parla di "sovraccarico professionale e intasamento dei tempi di vita quotidiani". Un prete sempre in macchina per raggiungere le varie parrocchie, come un commissionario del sacro. E il rischio è proprio quello di diventare un burocrate del sacro. Quanto questo possa essere stressante lo dice la stessa contraddizione tra sacro e burocrazia. Ne nasce una routine spersonalizzante che riduce il prete a distributore. (...) Al prete inoltre sono richieste una serie di competenze: quelle biblio-liturgiche connesse alle celebrazioni; quelle relazionali e cioè di accompagnamento spirituale; quelle di "governo" delle parrocchie che comportano anche competenze amministrative. Insomma un sovraccarico di lavoro. Lo studio arriva a parlare perfino di "burn-out", termine inglese per dire crisi professionale. Luciano Tavazza l'ha tradotto in italiano con "cortocircuito". E' quello stato d'animo per cui uno si sente svuotato di energie, il suo lavoro lo annoia e vive i rapporti con le persone con distacco. Fino al punto, dice Castegnero, da cadere nella "crisi spirituale e di senso" e percepire la propria vita come "fallimento vocazionale". Qualcuno potrà dire che a un prete non dovrebbe succedere perché ha il sostegno della fede. Mi è accaduto ancora di sentire bollare certe crisi come "mancanza di fede". E che cosa c'è di più drammatico per un prete del sentir venir meno la fede? C'è poi il tasto dolente della solitudine. Si parla di solitudine ecclesiale alludendo ai rapporti con l'autorità ecclesiastica e con i confratelli sacerdoti. Per il primo aspetto si annota che dagli uffici centrali della diocesi "i preti vorrebbero sostegno e accompagnamento e invece ottengono direzione". Con i confratelli c'è cameratismo anziché amicizia. Solitudine pastorale percepisce il prete quando il contesto "apprezza il prete per quanto fa e rappresenta, ma rimane distaccato e garbatamente indifferente verso quanto testimonia e annuncia". Esemplificando: non è consolante sentirsi dire "voi preti dovete dire così, ma noi abbiamo altre preoccupazioni e altri compiti'. Questo vale soprattutto nei rapporti con i laici che frequentano anche la chiesa, vanno regolarmente a Messa, ma i messaggi che vi ascoltano anche dalle omelie del prete volano alti come teorie bellissime, ma non si impastano con la vita quotidiana. E allora anche il prete è "icona" posta in alto e ben incorniciata. Il che vuol dire nuovamente solitudine. Dorata fin che volete, ma fredda solitudine. Mentre il prete, come ogni uomo, ha bisogno di amicizia sia dei suoi confratelli preti e del vescovo sia dei laici. Ho notato maggior entusiasmo nei nostri preti "fidei donum" che sono andati in missione nelle nuove Chiese dell'America Latina. Non per nulla tendono a ritornarvi. E la ragione ritengo stia nel fatto che mentre lì è la gente che cerca il prete, qui è il prete che deve andare a cercare la gente. Sia ben chiaro che il prete non vuol essere coccolato, ma sentirsi persona tra le persone questo sì. Ho detto persona non personaggio.
- Dettagli
di Massimo Gramellini
Gli elenchi declinati da Fini e Bersani in tv non erano elenchi ma frasi fatte. Invitati a usare il linguaggio evocativo delle «classifiche», i due hanno tracimato nel comizietto, confermandosi politici di un altro secolo. Destra e sinistra sono termini ormai pigri per definire quel che ci succede. Le ideologie da cui prendono le mosse si suicidarono entrambe nel Novecento. Quando, dopo aver conquistato il potere con l'obiettivo di cambiare l'essere umano, lo condussero nei lager e nei gulag. Da allora destra e sinistra hanno rinunciato a qualsiasi velleità di palingenesi. Non puntano più a migliorare l'individuo, stimolandolo a essere più responsabile (la destra) e più spirituale (la sinistra). E di fronte allo sconquasso del mondo - con la ricchezza che abbandona l'Europa e gli Usa per spostarsi altrove - si limitano a narrazioni consolatorie dell'esistente.
L'ex destra, che da noi è berluscoleghista (Fini rischia la fine del vecchio Pri, che piaceva a tutti ma votavano in pochi), invita gli elettori ad andare orgogliosi di ciò che la destra detestava: l'aggiramento delle regole e il disprezzo della cultura, sinonimo di snobismo improduttivo. L'ex sinistra continua a raccontarsi la favola che l'italiano medio sia vittima di Berlusconi, mentre l'italiano medio è Berlusconi, solo più povero. Così si ritorna al punto di partenza: la società non cambia se vince un leader o un altro. Cambia se cambiano gli individui. Ma è un lavoro duro: più comodo continuare a scornarsi fra destra e sinistra, illudendosi che esistano ancora.
- Dettagli
Il risultato di una ricerca indipendente inglese: nella scala di pericolosità gli alcolici battono eroina e crack
L'alcol è più dannoso per la salute di cocaina, cannabis o ecstasy ed è lo "stupefacente" più nocivo in relazione al suo impatto sulla società. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista inglese Lancet, che riporta i risultati di una ricerca condotta da David Nutt, l'ex consigliere del governo laburista per la lotta alla droga, suggerisce che il danno complessivo prodotto dagli alcolici batte quello di crack e eroina e richiede dunque strategie coraggiose sul fronte della sanità pubblica.
Lo studio riapre il dibattito sulla classificazione degli stupefacenti in Gran Bretagna e sulla necessità di una campagna contro l'alcolismo. Se le droghe fossero classificate per il danno che producono, sostengono Nutt e i suoi colleghi dell'Independent Scientific Committee on Drugs, gli alcolici dovrebbero rientrare nella categoria "A", con l'eroina e il crack. Nella classificazione su una scala di pericolosità da 1 a 100 l'alcol è a quota 72, l'eroina a 55 e il crack a 54. (...)
- Dettagli
(...) Ma il clou della serata sono stati gli elenchi di Pier Luigi Bersani e di Gianfranco Fini, definiti rispettivamente «valori della sinistra» e «valori della destra». Senza un briciolo di espressività, Bersani ha fatto la lista dei classici luogocomunismi: lavoro, giustizia sociale, energia pulita. Un po' più vivace Fini: la destra è aver fiducia negli italiani, essere solidali e generosi, la destra è avere istituzioni politiche autorevoli, rispettate. La cosa che lascia perplessi è che ormai «destra» e «sinistra» sono vecchie e agonizzanti categorie storiche, da tempo inutilizzabili come categorie del pensiero. Parlare ancora di «valori di destra» o di «valori di sinistra» è una sorta di coazione karmica o, come direbbe Daria Bignardi, di pesantezza karmica. Ha ancora senso andare avanti con queste etichette? (...)
Aldo Grasso sul Corriere
Non condivido il taglio che Grasso dà alla sua interpretazione della trasmissione di Fazio e prendo la sua citazione solo per agganciarmi a dire ciò che tutti avranno registrato: il linguaggio della politica non parla come parla la tv. E oggi la gente parla (e pensa) come (e ciò) che parla la tv. Destra e sinistra dicono cose che meriterebbero di essere ascoltate, ma lo dicono in un linguaggio inascoltabile. Non è solo lo share che cala quando si devono ascoltare certe cose... Si "devono", non si ha il piacere di ascoltarle. E gli uomini di Chiesa soffrono della stessa malattia e non se ne rendono conto: dicono la Notizia più bella della storia nel modo più vecchio e inudibile del mondo! Mister B. parla il linguaggio della tv: l'ha plasmato fin dalle origini con il suo linguaggio e la tv porta la sua immagine e somiglianza. E la gente è stata clonata a sua immagine e somiglianza. Però c'è anche qualcun'altro che parla in modo diverso: non serve fare nomi, ma forse Vendola nel campo della politica è l'unico che vi riesce senza essere figlio e schiavo della tv. Non vorrei vivere così a lungo da vedere un "elenco" (immaginate poi di cosa!) letto nella trasmissione di Fazio da un prete o da un vescovo...
- Dettagli
- Dettagli
- Dettagli
di Erri De Luca
Sul bianco di una pagina di libro mi è venuto di scrivere per dedica a un'amica: «Benvenuta nel secolo senza uomini». Sento di assistere e di partecipare anch'io a una decadenza del genere maschile, di vederlo vacillare davanti al femminile con sgomento fino alla furia di scagliarsi contro. Giovani donne vengono così ammazzate. L'arroganza virile era asfissiante nel sud della mia infanzia. Il rapporto di soggezione, il governo maschile, aveva un solo punto di cedimento: di fronte alla mamma napoletana, che aveva in dote per proverbio di poter bastare a cento figli. Questo sud cullato e incallito in rapporti di forza e prepotenza che sancivano l'assoluzione per l'omicidio d'onore, è stato sbaragliato. L'acquisto di una nuova dignità femminile è stato risentito come una perdita di prerogative anziché come una grandiosa liberazione di risorse. Il maschile, se respinto s'ingolfa di risentimento. Sente leso il suo diritto all'amore, questo potente contratto di alleanza, meraviglioso da stabilire, scorticante se rifiutato. Si tratta di amore e il maschile non lo sa più trattare. Nel libro sacro Genesi/Bereshit, al momento dell'espulsione dal giardino, Eva riceve per condanna di provare una forte attrazione per l'uomo. Una «piena/ teshukà » è la parola impetuosa scelta dall'antico ebraico. La donna è provvidenzialmente soggetta a questa forza d'attrazione, senza la quale il genere umano non sussisterebbe. Il nostro maschile si trova oggi di fronte a una potente dignità femminile combinata con una nuova capacità di seduzione fisica, indotta da una società che costringe alla bellezza delle forme. Ma se la donna, più forte e più bella di prima non ci sta, non obbedisce alla condanna dell'attrazione e può reagire con nuovi diritti, ecco che il maschile vacilla, si sente perduto, intimamente deriso. Giovani donne vengono così ammazzate. La canzone napoletana, scritta da uomini, gronda di cuori strapazzati da donne spietate. L'uomo allora aveva la forza virile di cantare, di aggrapparsi a serenate per accendere finestre chiuse, forzare persiane. Era all'altezza della sua pena e della donna che si negava inespugnabile. L'uomo aveva accanto all'eterno coltello la chitarra, la musica, la voce e, al peggio della disperazione, la dignità di andarsene, emigrare anche. Oggi si leggono storie di furia esplose dentro l'impotenza, di maschi scatenati all'odio da un nuovo analfabetismo sentimentale, dallo sgomento di essere, di fronte a una donna desiderata, l'appendice del niente.
- Dettagli
 Il giornale di partito "Avvenire" si sbilancia in prima pagina...
Il giornale di partito "Avvenire" si sbilancia in prima pagina...
Servi.
- Dettagli
- Dettagli
mons. Tonino Bello
Miei cari fratelli,sono molto contento di venire in mezzo a voi proprio la prima domenica di Avvento.
La liturgia,sotto le apparenza di un linguaggio catastrofico, ci parla di speranza; ci rende una notizia straordinaria, per la quale forse non riusciamo a scaldarci più perchè siamo diventati vecchi, o perchè queste parole ce le sentiamo ripetere da secoli, e non proviamo più trasalimento.
Che cosa ci dice l'Avvento? Avvento significa "venuta". La celebrazione di oggi, miei cari fratelli, vuole dirci che Gesù è venuto.
Voi replicherete:"Ma questo lo sapevamo già,cosa ci annunci di nuovo? E' una notizia antica, non ci dice più niente!"
Ma come: "Non ci dice più niente!"
Cari fratelli,Gesù è venuto duemila anni fa. Si è fatto uomo come noi: è sceso,ha penetrato gli strati dell'universo ed è arrivato nel cuore della terra. E' diventato come noi: sorriso umano, sofferenza umana, linguaggio umano, volto umano...
Gesù Cristo ha messo la tenda dove dormiamo noi,è diventato nostro contubernalis. I latini dicevano così dei loro compagni d'armi, che dormivano sotto la stessa tenda: contubernalis,perchè dormivano due a due.
E' diventato, dunque, nostro compagno di tenda. Dorme con noi, Gesù Cristo! Ed è nostro compagno di viaggio: cammina con noi, non ci lascia soli! Ed è diventato nostro compagno di tavola, commensale nostro.
Questo, cari fratelli, dovrebbe veramente riempirci il cuore di felicità, perchè sperimentiamo tutti, a partire da me,la solitudine e la sofferenza, l'abbandono, l'incapacità di comunicare con gli altri: sperimentiamo l'avvilimento, non è vero? Chi di noi può dire che il sorriso che gli spunta sulle labbra coincide con il sorriso dell'anima? Quanti orpelli mettiamo ai nostri sentimenti interiori... per cui a volte abbiamo l'anima lacerata e traduciamo tutto questo con un sorriso fugace che si spegne subito!
- Dettagli
 Non seguo questa trasmissione e forse "per lavoro" dovrò farlo... ma se il buongiorno si vede dal mattino, lo spot mi lascia molto perplesso. Posso pensare che questo modo "leggero" sia accattivante per il pubblico giovane, ma che la conduttrice si presenti così mi pare un tradimento della serietà degli argomenti. Che possono essere affrontati in modo accattivante e comprensibile senza cadere nella banalità e nel populismo. Un'idea positiva c'è: per vivere bene la sessualità bisogna informarsi e formarsi. Come lo faccia questa trasmissione... potrebbe nascondere una delusione.
Non seguo questa trasmissione e forse "per lavoro" dovrò farlo... ma se il buongiorno si vede dal mattino, lo spot mi lascia molto perplesso. Posso pensare che questo modo "leggero" sia accattivante per il pubblico giovane, ma che la conduttrice si presenti così mi pare un tradimento della serietà degli argomenti. Che possono essere affrontati in modo accattivante e comprensibile senza cadere nella banalità e nel populismo. Un'idea positiva c'è: per vivere bene la sessualità bisogna informarsi e formarsi. Come lo faccia questa trasmissione... potrebbe nascondere una delusione.- Dettagli
di Massimo Gramellini
Una multinazionale finanziaria è nei guai perché gli impiegati della sede di Dublino hanno stilato la classifica delle dieci colleghe più carine. A coloro che si indignano, e pare siano tanti, non serve dire che si tratta di una pratica diffusa negli uffici più o meno da quando uomini e donne hanno cominciato a lavorare insieme. Prima però le classifiche erano pezzi di carta che giravano di mano in mano (confesso di aver partecipato anch'io, vent'anni fa, a quella sulle giornaliste di Montecitorio), alimentando le viscere di una cerchia ristretta. Mentre adesso c'è la posta elettronica e i verdetti dei giurati di Dublino sono ovunque la Rete allunghi i suoi subitanei tentacoli, trasformando un gioco forse di cattivo gusto, ma sostanzialmente innocuo, in uno scandalo.
Sarà dunque il computer a costringerci a rigare diritti, come non riesce più alla Chiesa, alla scuola, alla famiglia, a nessuna autorità morale? La tecnologia ci ha riempito la vita di «scatole nere» che fissano per sempre i nostri peccati. Una parola, un messaggio, un gesto compromettente non evaporano più nell'atmosfera complice di una stanza chiusa, ma vengono immortalati da uno schermo e da lì proiettati in ogni orecchio e occhio affamati di curiosità malevola. Non c'è scampo, non c'è redenzione: le macchine non rimuovono il dolore come noi. Lo diffondono soltanto. Rispetto al passato, è cambiata la paura del castigo: invece dell'inferno, lo sputtanamento universale. Ma anche questo è in linea coi tempi, più interessati alla reputazione di un attimo che alla vita eterna.
- Dettagli
- Dettagli
- Dettagli
- Dettagli
561 euro è la cifra che una famiglia media italiana perde ogni anno non consumando tutta la spesa
Libro nero accusa: tra campagne, industrie e famiglie, ogni anno sprechiamo 3,7 miliardi di alimenti
di Giuseppe Salvaggiulo
Lo spreco alimentare ha molte facce e genera una filiera, parallela a quella produttiva ma in senso contrario. Si spreca nei campi agricoli, nelle cooperative, nelle industrie di trasformazione, nelle imprese di distribuzione, nelle case dei consumatori. E così rinunciamo al 26% del pesce, al 36 dei cereali, al 41 della frutta e della carne, al 48 delle verdure. Buttiamo ogni anno 3,7 miliardi di euro, il valore di una media manovra economica, lo 0,3 per cento del Prodotto interno lordo. Non siamo i soli: secondo la Fao, la produzione agricola mondiale potrebbe nutrire 12 miliardi di persone. Ma questa è una magra consolazione. Il Libro nero sullo spreco agroalimentare in Italia oltre a denunciare il volume degli sprechi, gli esperti ne analizzano le cause, individuano gli anelli della catena in cui avviene la «dispersione», provano a proporre soluzioni. Teoricamente, ogni italiano dispone ogni giorno di 3.700 chilocalorie di cibo: una volta e mezza il suo fabbisogno energetico. In realtà, «l'eccesso di calorie a disposizione degli italiani non sempre, anzi quasi mai, viene consumato» (se così fosse, l'intera popolazione soffrirebbe di obesità, mentre «solo» il 67% degli uomini, il 55 delle donne e il 33 dei bambini è in sovrappeso). In gran parte, dunque, l'eccesso di calorie a disposizione «viene perso lungo tutta la filiera. Ogni giorno, una certa quantità di cibo, pur essendo perfettamente consumabile, viene gestita come rifiuto». Un paradosso con conseguenze pesanti sotto diversi punti di vista: alimentare, ambientale, sociale, economico.
Il primo anello della catena è lo spreco nei campi. L'anno scorso, secondo i dati Istat, 17,7 milioni di tonnellate della produzione agricola è rimasta sui campi. Si tratta del 3,3 per cento. I picchi riguardano gli ortaggi (12,5), legumi e patate (5,2). I motivi? «Si va da ragioni meramente estetiche a quelle commerciali (prodotti fuori pezzatura) o di mercato (costi di raccolta superiori al prezzo di mercato)». «La quantità di ortofrutta sprecata nel 2009 avrebbe potuto soddisfare le esigenze di una seconda Italia, o di una Spagna».
Il secondo anello è lo spreco nelle cooperative o organizzazioni di produttori. In un anno 73 mila tonnellate di prodotti vengono ritirati dal mercato per evitare il crollo del prezzo (tra le destinazioni, il compostaggio e la distillazione). Di questi, solo il 4 per cento non viene sprecato. Con un ulteriore paradosso. L'Ue finanzia l'acquisto e la distruzione di questi prodotti. «Un controsenso, uno spreco nello spreco. Contemporaneamente si finanziano gli agricoltori per rimanere in campagna per produrre e la distruzione di parte di quei prodotti».
«Anche l'industria alimentare non è scevra dagli sprechi». Un'indagine a campione stima la dispersione in 2 milioni di tonnellate di prodotti, il 2,2 per cento. In gran parte, diventano rifiuti (un costo aggiuntivo). Quanto ai mercati all'ingrosso e alla distribuzione organizzata, la quota di spreco è stimata intorno all'1 per cento. Anche in questo caso, per «motivi di mercato».
«La situazione è ancora peggiore passando all'ultimo anello»: noi consumatori. Nelle mense scolastiche lo spreco raggiunge il 13-16 per cento, nelle famiglie il 17 sull'ortofrutta e il 39 su latte, uova, carne, formaggi. Le cause sono le stesse: «eccessi di acquisti e danneggiamento/deterioramento del prodotto per eccesso di giacenza in dispensa».
Gli esperti hanno misurato l'impatto sociale, economico e ambientale dello spreco. E infine provano a rispondere alla domanda: che fare? Due le proposte: favorire la conoscenza del problema a ogni livello, per far crescere la consapevolezza soprattutto nei consumatori, e promuovere politiche fiscali che incentivino i comportamenti virtuosi. L'esempio è la tariffa sui rifiuti: dove funziona bene (l'esempio citato è Verona) è possibile ottenere uno sconto su quanto viene donato e non gestito come rifiuto. L'effetto è duplice: chi non spreca risparmia 100 euro per ogni tonnellata di frutta o verdura e consente di nutrire mille persone al giorno.
- Dettagli
di mons. Giuseppe Casale
Per i cattolici italiani è giunto il tempo di un severo esame di coscienza. Quali responsabilità di fronte ai guasti della vita pubblica che si fanno ogni giorno più gravi? E non parlo solo dei quotidiani scandali che riempiono le pagine di cronaca. Parlo del degrado della vita politica e della tranquilla accettazione di un metodo di governo che promette illusioni e lascia affogare il Paese nella “monnezza”. Non solo a Napoli e a Palermo, ma dovunque si vive di malaffare, di illegalità, di soprusi. Come hanno reagito i cattolici all'indegno trattamento riservato a migliaia di migranti (tra cui tanti profughi) respinti in veri campi di concentramento? Invece di reagire all'operato del governo, hanno applaudito o tacitamente acconsentito, preferendo difendere il loro risicato benessere, che si fa ogni giorno più precario. Chi ha levato la voce contro una situazione del lavoro che vede disoccupati migliaia di giovani e costringe tanti operai a sopravvivere con la cassa integrazione? Non è sufficiente tenere in regola i conti dello Stato. Questo può farlo qualunque buon ragioniere. È urgente un'azione che ponga fine agli squilibri esistenti tra chi ha molto (in alcuni casi, troppo) e chi non ha niente, tra chi sguazza nel lusso e chi stenta a mettere insieme quanto serve per le quotidiane necessità. Abbiamo detto molte belle parole. Ma non abbiamo avuto il coraggio di denunciare i mali di un capitalismo globalizzato che aumenta i dividendi delle anonime finanziarie (vere centrali di ingiustizia) e tratta gli operai come merce di scambio. Quanti cattolici che si riempiono la bocca di dottrina sociale cristiana sono pronti ad impegnarsi di persona, non per la conquista di un pezzo di potere, ma per un cambiamento che ponga al centro del dibattito i temi della pace, del disarmo, della solidarietà? È giusto difendere la vita dall'inizio alla sua conclusione. Ma è ancora più urgente difendere la vita di milioni di bambini che muoiono di fame. È ancora più urgente impegnarsi per la pace tra i popoli, scoraggiare i risorgenti nazionalismi. Il governo, invece di far propaganda per innamorare i giovani per la vita militare, li aiuti a inserirsi nel mondo del lavoro, crei tutte le occasioni per non lasciare inoperose migliaia di braccia e di menti, per cui tanto si è speso negli anni della formazione scolastica. Ai cattolici dico: è tempo di agire. Non sognando un nuovo partito cattolico o di cattolici. Non mirando a una fetta di potere. Ma operando in tutti i settori della vita pubblica con una coraggiosa testimonianza di onestà e di competenza. Ai cristiani di Roma Paolo lanciava un forte monito: “È ormai tempo di svegliarvi dal sonno” (Rm 13,11). Abbiamo dormito troppo. Abbiamo troppo pensato al nostro interesse personale, a una sterile difesa dei diritti della Chiesa. I diritti della Chiesa sono i diritti dei poveri, degli emarginati, degli esclusi, degli oppressi da una società che riesce ad attutire o a spegnere qualunque sussulto di rivolta contro l'imperante conformismo. Di quel perbenismo che concilia il dirsi cattolico e il vivere una vita di immoralità e di menzogna. È ormai indilazionabile l'impegno a porre a base della nostra vita non la ricerca del potere, ma il servizio, praticando la carità che è la “pienezza della legge” (Rm 13,1). Non c'è legalità se non c'è un forte sussulto di amore, di gratuità, di condivisione.
in “Adista” - Segni nuovi
- Dettagli
- Dettagli
di Alessandra Comazzi
Benigni esausto che canta «E' tutto mio» è stato un gran pezzo di televisione. E «Vieni via con me» è stato soprattutto teatro in televisione. Quelle tre ore di elenchi, monologhi, canzoni, sembravano ciò che di più antitelevisivo si possa dare, in questi video-tempi veloci e affrettati, fatti di slogan e non di ragionamenti. Il programma di Fabio Fazio ha invece riscoperto il valore della parola. Non a caso, di sfondo, stavano le pietre millenarie di un teatro greco. Con orgoglio intellettuale, il riferimento non detto era al Verbo, «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio». Orgoglio ma non presunzione, perché la presunzione è fatta di improvvisazione e di superficialità e di scarsa conoscenza dei mezzi propri e altrui. Fazio invece è così: si prepara, e cerca il meglio su piazza, inseguendo il pensiero trasversale. In fondo fu lui a portare Gorbaciov e il Nobel Dulbecco sul palcoscenico di Sanremo. Ebbe un successo ancora ineguagliato, pure quantitativo, e in fondo quel Festival segnò la via.
Canta Daniele Silvestri il fondamentale brano di Gaber «Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono», e a poco a poco la parola «italiano» trascolora e diventa «Saviano». Fazio aveva cominciato questo spettacolo che è una citazione di Paolo Conte, con una serie di elenchi alla Hornby, i buoni motivi per costruire una moschea a Torino, i mestieri di una giovane neolaureata. Poi è arrivato Nichi Vendola a dire i modi in cui si può definire l'omosessuale. E Abbado ha elencato i motivi per cui è sbagliato tagliare i fondi alla cultura.
All'Italia e alla mafia era dedicato il monologo di Saviano, lungo una buona mezz'ora. Mezz'ora è molto lunga in tv. Lui l'ha saputa gestire con foga oratoria, richiami a Falcone e Borsellino, la lucida indignazione sulla macchina del fango, che ricopre chi si schiera «contro questo governo. Viene attaccata la vita privata, e chi deve scrivere ha paura. Così si attacca la libertà di stampa, di informazione». Luci splendide, primi piani gloriosi. Poi è arrivato Benigni: (...).
- Dettagli
- Dettagli
del card. Carlo Maria Martini
Esce martedì da Mondadori il nuovo volume dell'arcivescovo emerito di Milano. Anticipiamo i testi introduttivi ai capitoli, nei quali il cardinale Martini riflette sulle tappe della vita.
BAMBINI - I fanciulli si pongono tante domande che nascono dalla curiosità e dalla meraviglia che suscita in loro l'esperienza dell'essere. Spesso queste domande non vengono prese sul serio dagli adulti; invece emergono dal profondo e sono da tenere in considerazione: il continuo interrogare dei più giovani è indice di una capacità spontanea e innata di vedere a fondo le cose. Mi pare che anche per questo i bambini siano lodati da Gesù e proposti come modelli. L'episodio in cui tali domande emergono con particolare vigore, e sono fondate, valutate e accolte, è quello che narra la permanenza di Gesù al tempio all'insaputa dei suoi genitori. Qui Gesù sperimenta la forza che lo lega al Padre e che si esprime anche nelle istituzioni del tempio. Ma tale presenza del divino è spesso ostacolata: Gesù nella sua vita pubblica si scontrerà sovente con questo ostacolo, che emergerà anche nel rapporto con la classe sacerdotale, e sarà una delle cause che lo porteranno alla crocifissione. L'atteggiamento di Gesù mostra l'importanza che può assumere la decisione di un dodicenne. Di fronte a tale scelta noi abbiamo la sensazione di procedere su un terreno sacro, a cui bisogna avvicinarsi con rispetto. Anche i fanciulli sono quindi capaci di conoscere Dio spontaneamente e di avvicinarsi a lui. Essi sono abilitati a essere uditori della Parola e sono capaci di compiere scelte coraggiose.
***
GIOVANI - La giovinezza è l'età dei grandi sogni, che presentano un quadro ideale della vita dell'uomo, ed è per questo che i giovani sono di solito molto critici del mondo così com'è. Bisogna saperli aiutare rispettando le loro esigenze di perfezionismo e condurli, nello stesso tempo, a non spaventarsi di fronte alle realtà della vita. La giovinezza è anche il tempo dei grandi amori e delle grandi speranze. È necessario non deludere le attese dei ragazzi, saperne sfruttare l'idealità e insegnare loro che la realizzazione di un ideale di solito richiede tempi lunghi. Bisogna inoltre accompagnarli verso l'accettazione del fatto che noi non siamo perfetti. La figura concreta di questa idealità è Gesù che si reca nel tempio a pregare e scaccia i mercanti, che rendono quel luogo una spelonca di ladri. La giovinezza può pure essere il tempo della contestazione, della ribellione e del rifiuto, come è normale che sia. Ma secondo un proverbio indiano, questa è anche un'età in cui si è chiamati a insegnare: ciò comporta una responsabilità che fa da contrappeso alla voglia di respingere la tradizione. Tale responsabilità ha un grande valore per sostenere le persone nella vita.
***
ADULTI - L'età adulta viene definita da quello stesso proverbio indiano come un ritirarsi nel bosco. L'adulto deve saper riconoscere i suoi limiti e fare anche un passo indietro, se necessario. L'adulto ha una visione complessiva di come vanno le cose in questo mondo. Ciò, però, non deve diventare motivo per limitare gli ideali, ma deve essere stimolo per giungere a una visione esatta della realtà. Bisogna considerare che ci sono almeno due tipi di adulti: quelli che si lasciano trascinare dal vortice degli impegni e quelli che sanno prendere tempo per far maturare i propri principi. Solo quest'ultimi meritano in pieno il titolo di adulto. Quanto più uno cresce in responsabilità, tanto più sono necessari momenti di ritiro e silenzio. L'adulto è in grado di riflettere su di sé e ciò gli dà la possibilità di confrontarsi con la propria fede. È difficile uscire del tutto da sé per effettuare quella che è chiamata la «conversione», perché essa comporta un totale rivolgimento della visione della realtà. Ci si domanda quanti uomini giungano alla piena conoscenza di sé. Secondo gli psicologi tale conoscenza non può aversi prima dei trentacinque/ quarant'anni, ma non molti giungono a un simile punto di maturazione. È questo il motivo per cui si diffondono visioni semplicistiche del mondo e dell'uomo. Perciò il parere della maggioranza non è senz'altro una garanzia per la verità.
***
ANZIANI Per la spiritualità indù la rinunzia ai propri beni significa la capacità di presentarsi con la mano destra aperta per ricevere umilmente il pane quotidiano. Tradotto nel linguaggio della cultura occidentale significa che occorre sempre più riconoscere che la nostra vita dipende dagli altri e godere di questo fatto. È certamente difficile per i ricchi sopportare di diventare poveri, come dimostrano gli esempi evangelici di Nicodemo e del giovane ricco, ma in questo si può gustare una partecipazione più autentica al Vangelo. Fa parte di tale impoverimento anche l'indebolimento fisico cui si va incontro con il passare degli anni. Perciò il Vangelo di Giovanni, che esemplifica il cammino del cristiano ed è un Vangelo segnato dalla profondità mistica, riduce tutto all'essenziale. I vecchi devono imparare a ritirarsi dalle loro responsabilità e contemplare maggiormente l'unità delle cose. In questo senso l'anzianità può durare molto meno delle altre fasi della vita e non dipende dall'età anagrafica. Ciò significa che le età della vita non possono ridursi solamente alla biografia. Esse hanno una durata diversa che non è possibile determinare a priori. Bisogna interpretare ciascuno alla luce di un cammino spirituale che tenga conto della maturità raggiunta. Anche lo stile di preghiera varia nelle diverse età della vita. È molto importante vedere se la nostra preghiera corrisponde o meno alla nostra età. La preghiera, infatti, matura via via con la ricchezza interiore, ma nel tempo della vecchiaia può tornare a essere semplice e spontanea come quella dei fanciulli.
- Dettagli
Adolescenti, sms e iPad prima di dormire disturbano il sonno
Insonnia, ansia e depressione sarebbero conseguenza diretta dell'uso smodato, prima di andare a letto, di cellulari e pc: indagine su ragazzi dagli 8 ai 22 anni
Mandar messaggi col telefonino fino a notte fonda dal letto, o leggere un libro sull'iPad invece che spegnere la luce e provare ad addormentarsi, da innocue attività potrebbero trasformarsi in pericolose abitudini per la salute dei ragazzi. Causando, a lungo andare, problemi legati all'ansia, alla depressione, o patologie precise come l'ADHD, sindrome da deficit di attenzione e iperattività, così come insonnia. Lo sostiene uno studio clinico svolto nel New Jersey, al Centro dei disordini del sonno della cittadina di Edison, che ha monitorato il ritmo circadiano di circa 40 pazienti, analizzandone nel lungo periodo le abitudini tecnologiche del pre-sonno e la qualità dello stesso. Questa ricerca è solo l'ultima di una lunga serie, che in questi mesi hanno messo in guardia sulle abitudini errate prima di coricarsi.
Sotto la lente dei ricercatori del New Jersey sono passati ragazzi dagli 8 ai 22 anni (l'età media era di 14,5 anni). Una quarantina in tutto, che sono stati anche ricoverati per analizzarne il ritmo di sonno nelle ore notturne. Tra loro, il 77 per cento denunciava di avere problemi di stanchezza, o nell'addormentarsi. I ragazzi ammettevano anche di mandare fino a 33 messaggini (o email) a una media di 4 persone diverse prima di chiudere gli occhi, altri confessavano di passare parecchie ore a giocare ai videogiochi, altri ancora a navigare su internet, leggere su iPad o altri lettori di ebook. Con una differenza tra maschi e femmine, ma anche a seconda delle età: i primi passano più tempo a giocare, le seconde a mandare sms. E con il crescere degli anni, aumentano anche i volumi di messaggi scambiati.
Tali abitudini portano i soggetti analizzati a disturbare il loro sonno, arrivando al momento dell'addormentarsi troppo eccitati dall'uso della tecnologia. Nel caso degli sms per esempio, l'attesa della risposta, anche una volta che il messaggio è stato spedito, fa sì che il sonno non inizi in modo "igienico", ma carica di ansia e aspettative un momento che dovrebbe essere di grande calma e rilassamento. Questo stato mentale è ancor peggio del bombardamento di immagini e suoni dato dalla televisione, o dall'ascoltare musica. Proprio l'interazione poi, come avviene se si gioca o si naviga in rete, è altrettanto colpevole dell'eccitazione pre-dormita. La soluzione, raccomandano gli esperti ricercatori che hanno svolto lo studio, è controllare i ragazzi e convincerli a spegnere pc e dispositivi elettronici almeno un paio di ore prima dell'ora del sonno. E il consiglio vale anche per gli adulti, che tanto quanto i ragazzi inquinano il loro riposo con ogni genere di dispositivo, spesso usato anche a letto.
- Dettagli
«Vi dirò di me stesso che sono un figlio di questo secolo, un figlio dell'incredulità e del dubbio, fino ad oggi e forse fino alla tomba. Quali spaventose torture mi è costata e mi costa anche ora questa sete di credere, tanto più forte nella mia anima quanto ci sono in me argomenti contrari. E tuttavia, Dio mi invia talvolta dei momenti in cui tutto mi è chiaro e sacro. È in quei momenti che ho composto un credo: credere che non c'è nulla di più bello, di più profondo, di più amabile, di più ragionevole e di più perfetto che il Cristo, e che non solo non c'è niente, ma, e me lo dico con un amore geloso, che non si può avere niente. E più ancora, se qualcuno mi avesse dimostrato che Cristo è fuori dalla verità, avrei preferito senza esitare restare con Cristo piuttosto che con la verità».
- Dettagli
Queste parole mi fanno sempre molta impressione, perché non mi è mai capitato di dire: «La mia anima è triste fino alla morte»; ci sono stati momenti di tristezza, ma proprio di essere schiacciato, di essere stritolato non mi è mai successo. Penso quindi che a Gesù sia accaduto qualcosa di terribile. Che cosa sarà stato? Probabilmente la previsione imminente della passione; forse Gesù non sapeva tutti i particolari, ma sapeva che gli uomini ce l'avevano con lui, volevano eliminarlo nella maniera più crudele possibile. Sapeva di essere in mano a uomini cattivi: questo è già un motivo di paura e di angoscia. Ma poi probabilmente sentiva su di sé tutta l'ingiustizia del mondo e questo è qualcosa che non si può sopportare; l'ingiustizia del mondo che si esprime nelle guerre, nelle carestie, nelle oppressioni, nelle forme di schiavitù, che è immensa e percorre tutta la storia. E quando noi ci fermiamo a considerare questa ingiustizia, siamo come senza fiato, siamo schiacciati.
Però Gesù ha voluto essere quasi schiacciato da queste cose per poterle prendere su di sé. Quindi dobbiamo dire che da una parte le ingiustizie del mondo, della storia, della storia della Chiesa ci fanno soffrire, ma che insieme siamo certi che Gesù le ha accolte in sé, e quindi le ha riscattate. Non sappiamo come, ma questa è una certezza che ci deve accompagnare, e ci deve accompagnare in tutte le notti della sofferenza, del dolore, quando uno si trova di fronte a una notizia che lo riguarda e che è infausta. Per esempio un tumore, pochi mesi di vita. Allora succede come una sorta di ribellione, di non accettazione. C'è una lotta interiore. Notte della sofferenza, notte della fede in cui non si sente più la presenza di Dio. Questo è molto duro, soprattutto quando si è impegnati. Notte della fede per cui sono passati san Giovanni della Croce e, recentemente, Madre Teresa di Calcutta, la quale diceva che fino a verso i cinquant'anni le pareva che Dio le fosse vicino, poi più niente. Avendola conosciuta, vedevo questo suo rigore, questa sua fedeltà, questa sua tensione, ma non immaginavo che dietro ci fosse il buio completo sull'esistenza di Dio, del Dio rimuneratore. Anche santa Teresa di Gesù Bambino è passata per questa notte. Possiamo dire che tutte queste notti sono riassunte nella notte del Getsèmani e in essa Gesù riceve tutte le nostre ingiustizie e le fa sue, le accoglie per poterle offrire e purificarle. Questa è una prima immagine che vi lascio.
Una seconda immagine è quella della tomba. Che cosa sia avvenuto il giorno di Pasqua, noi non lo sappiamo. La liturgia romana dice: «Beata notte, che non hai saputo il giorno e l'ora»; e noi non sappiamo niente, nessuno è stato presente, nessuno ce l'ha raccontato; però possiamo immaginarne le conseguenze. Lo descriverei così: un grande scoppio di luce, di pace e di gioia nella notte della tomba. Scoppio di luce, di pace e di gioia che è potenza dello Spirito, che prende prima di tutto il corpo di Gesù e lo vivifica, lo rende capace di essere intercessione per il mondo. Ma poi continua in ciascuno dei viventi suscitando in lui le disposizioni di Gesù. Mi pare quindi che sia troppo riduttivo dire: lo Spirito Santo è il segno dell'amore di Dio per me. Lo Spirito Santo è segno delle scelte di Gesù fatte mie. È quella forza, quel dinamismo, quella capacità di amare il povero, di amare il sofferente, di amare colui che si trova in situazione di ingiustizia perché così lo Spirito compie la sua opera. E noi possiamo dire che quest'opera si compie sempre quando Gesù dice: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,26). Vuol dire la sua presenza anche con il suo Spirito, con la sua capacità di vedere le cose, di reagire alle cose, di giudicare le cose.
Certo, occorre per questo un grande spirito di fede, perché molta gente dirà: «Io non vedo niente, io vedo le cose andare di male in peggio». Occorre l'occhio della fede per leggere negli eventi miei e intorno a me questa presenza dello Spirito Santo che costruisce il mondo nuovo, la Gerusalemme celeste, che non è una città nel cielo separata da qui, ma una città che viene dal cielo, cioè dalla forza di Dio e trasforma tutti i rapporti di questa terra. Nessuno meglio di Teilhard de Chardin ha descritto questa Gerusalemme celeste in cui vedeva appunto il termine finale, il punto omega della redenzione nel Cristo, dove tutta l'umanità era riunita e salvata, una e trasparente gli uni agli altri, e tutti noi verso Dio. Occorre tenere presente questo fine della storia, perché altrimenti siamo banalizzati dalle vicende quotidiane, oppure siamo sofferenti quando ci sono grandi calamità e non abbiamo nessuna chiave per interpretarle. E questa che vi ho detto non è una chiave logica, è una chiave mistica spirituale data dallo Spirito Santo: cercare di vedere in tutto l'azione dello Spirito che opera incessantemente.
- Dettagli
di Elena Loewenthal
Da domani battere il marciapiede o il ciglio della provinciale sarà più difficile e soprattutto più rischioso. In strada, beninteso. Perché se si è professioniste del più antico mestiere del mondo al calduccio della casa propria o altrui, da domani non cambierà proprio nulla. Per non parlare di quella ormai larga fetta di prestazioni erotiche che si avvalgono della rete e che, in virtù della liberalizzazione di segno opposto per il web [reti wireless], saranno agevolate invece che intimidite dalla stretta governativa.
La quasi ovvia considerazione che ne consegue è che tutto diventa più semplice se ci sono di mezzo i soldi. Bastano infatti un po' di dimestichezza con il computer per «ottimizzare» il contatto con la clientela, un letto sotto e un tetto sopra la testa, per prostituirsi in santa pace. Senza dover temere quel foglio di via che da domani sarà elargito rigorosamente alle prostitute in flagranza di reato. Cioè, sempre che il reato ci sia. Cioè, solo se il mercimonio è esercitato in un Comune in cui il sindaco abbia emesso un'ordinanza che ne vieta l'esercizio
- Dettagli
Dimitrij di Rostov,
"Sospiri dell'anima peccatrice verso Cristo, Figlio di Dio" (1899)
O amore puro, sincero e perfetto!
O luce sostanziale!
Donami la luce perché in essa riconosca la tua luce.
Donami la luce affinché io riconosca le tue viscere paterne.
Donami un cuore per amarti.
Donami orecchie per ascoltare la tua voce.
Donami l'odorato per sentire il tuo profumo.
Donami mani per toccarti, piedi per seguirti.
Sulla terra e nei cieli non desidero altro che Te, mio Dio!
Tu sei il mio solo desiderio, la mia consolazione,
la fine di tutte le mie angosce e sofferenze.
Non cerco che Te, in te solo è la mia gioia e la mia beatitudine.
Nel tempo e, come spero, nell'eternità.
- Dettagli
di Massimo Gramellini
E così, con le elezioni di Midterm, ci siamo giocati anche Obama. Magari si rifarà fra due anni, ma intanto ha perso l'aureola del messia che gli abitanti del pianeta Terra, non solo gli americani, gli avevano ansiosamente attribuito, obbedendo come sempre a un'emozione intensa ma superficiale, destinata a evaporare alle prime difficoltà. La tipica emozione di un mondo di individualisti che si ciba d'immagini, procede per suggestioni - la pelle nera, Yes We Can - e non crede più nei partiti e nei gruppi sociali, ma soltanto nel leader salvifico. Tanti uomini soli mettono un uomo solo al comando che in realtà non comanda quasi su niente. Cosa potrà mai fare una persona, anche di qualità eccelse, dentro un sistema economico che si muove per conto proprio, secondo dinamiche che la politica riesce appena a scalfire? La sala dei bottoni non ha più bottoni o forse ne ha troppi perché dall'altra parte risponda ancora qualcuno.
I cittadini non hanno smesso di sognare il cambiamento. Ma in assenza di un sistema organico di valori lo hanno delegato a singoli ambasciatori di un'emozione collettiva, caricandoli di responsabilità insopportabili e alimentando speranze che durano lo spazio di una campagna elettorale. Anche in Italia non ti chiedono più quali idee hai, ma se stai con Casini, con Vendola, con Berlusconi. Una biografia in cui ci si possa identificare per sentirsi migliori, una faccia alla quale appendere desideri confusi per poi ritrovarsi ogni volta disillusi, traditi. Avanti il prossimo.
- Dettagli
di mons. Jacques Noyer, vescovo emerito di Lilla
Agli Stati Generali del cristianesimo [Tre giorni di dibattiti e laboratori organizzati su iniziativa del settimanale cattolico “La Vie” dal 23 al 25 settembre all'Università cattolica di Lilla (http://www.lavie.fr/arches/page.php?sk=etatsgeneraux-christianisme.sk)], un laboratorio poneva la domanda: “Ci vuole un nuovo concilio?” Alcuni desideravano un nuovo concilio che chiarisse i punti di esitazione così dolorosi oggi nella nostra vita ecclesiale. Altri chiedevano ancora un po' di tempo perché fosse applicato il Concilio Vaticano II. Molti sembravano chiedere un concilio ogni 25 anni. Per quanto mi riguarda, vorrei che la mia Chiesa sapesse vivere in stato di concilio permanente. Una Chiesa in stato di concilio permanente è una Chiesa che ritiene che la Buona notizia chiede ogni mattina di essere ridetta in termini nuovi situati nell'attualità del giorno. È una Chiesa che rinuncia all'immagine di perfezione raggiunta che la imprigiona così spesso in un Diritto intangibile. È un intero Popolo di Dio che è implicato nelle iniziative da prendere e nelle risposte da dare al mondo che interroga. È una Chiesa in cui i teologi e i pastori lavorano insieme su problemi e situazioni reali. È una Chiesa che celebra la presenza dello Spirito da cui è inviata. Il Concilio Vaticano II si è curato di dare alla nostra Chiesa le istituzioni capaci di mantenere nel tempo lo slancio che lo aveva abitato. Tra le altre cose, ha istituito dei sinodi diocesani in cui ogni vescovo avrebbe ascoltato le attese e le proposte dei battezzati, delle conferenze episcopali per nazione in cui un certo numero di risposte potrebbero essere date e un sinodo romano permanente che permetterebbe ogni quattro anni ai vescovi eletti dalle conferenze attorno al papa di dare gli orientamenti più importanti di cui la nostra Chiesa ha bisogno. Questi tre organismi sono effettivamente stati istituiti. Ma niente permette davvero di dire che svolgono il ruolo che ci si poteva aspettare da loro. Il sinodo romano dà una grande libertà di parola a tutti i vescovi ma le decisioni da trarne sono decise in seguito solo dal papa. Le conferenze episcopali per nazione non hanno mai ricevuto lo statuto giuridico che avrebbe definito il loro ambito specifico di decisione e la loro autorità sui propri membri. I sinodi diocesani, che sono stati spesso dei momenti felici della vita delle nostre chiese locali, rimangono iniziative libere del vescovo e sono stati limitati da divieti che li sfigurano. Questi diversi ingranaggi, il cui interesse è indiscutibile, non permettono oggi ai cristiani né di sentirsi responsabili della loro Chiesa né di entrare nella gioia dello Spirito. Posso testimoniare che i vescovi, anche se ci tengono a fare bella figura, soffrono frequentemente per i continui ostacoli. Qualche teologo può trovare il proprio posto nel sistema attuale ma ne conosco molti che fanno fatica a trovare il loro vero posto nella Chiesa di oggi. Il clima generale creato dal papa e dalla curia romana non sembra favorevole a grandi aspettative da questi organismi, visti soprattutto come ingranaggi per far scendere verso la base le scelte di Roma. In una certa misura si potrà ricevere da loro qualche informazione, o qualche idea. Ma non si fa nulla per permettere ai cristiani di essere coinvolti nelle scelte pastorali concrete della loro Chiesa. Presentando così il cattivo funzionamento di questi tre organismi, propongo apparentemente dei cantieri inaccessibili ai vescovi e ai laici. Ma resto convinto che ciascuno al proprio posto può lavorarci. La teologia del popolo di Dio e della Chiesa locale è forse stata sotterrata? È forse stato deciso di chiudere le porte per proteggere il piccolo resto del popolo devastato? Da qualche parte c'è stato un concilio di cui non ci hanno parlato? Fino a prova contraria, reclamerò una Chiesa in stato di concilio permanente per la Felicità degli uomini e la Gioia di essere battezzato.
- Dettagli
di Massimo Gramellini
Davvero fosforica l'idea concepita dal Festival di Sanremo per i 150 anni dell'Italia unita: eseguire sul palco «Bella ciao» e «Giovinezza», rispettivamente colonna sonora della Resistenza e dei pestaggi squadristi. Erano italiani anche quelli, no? Come l'olio d'oliva e l'olio di ricino, la Costituzione e le leggi razziali. Ah, le forzature della par condicio! Perché le due canzoni non sono proprio la stessa cosa. «Bella ciao» è la torva nenia dei partigiani rossi ed evoca cosacchi a San Pietro e santori ad Annozero. Invece «Giovinezza» trasuda ottimismo spensierato: ti mette subito voglia di afferrare un manganello e scendere in strada a sgranchirti un po'. Come dite, organizzatori del Festival dell'Ipocrisia? «Giovinezza era l'inno della goliardia toscana del primo Novecento». Ma certo. E' per questo che è famosa. E' per questo che volete trasmetterla in eurovisione. Per rendere omaggio a quel fenomeno ingiustamente sottovalutato che fu la goliardia toscana del primo Novecento. E «Faccetta nera» allora, era lo slogan di una crema abbronzante?
Peccato che tanti italiani saliti in montagna o internati in Germania dopo l'8 settembre non siano più qui a commentare questo gemellaggio ardito (in ogni senso): vi avrebbero spiegato la differenza fra «Bella ciao» e «Giovinezza» meglio di me, anche se con toni meno ilari. Provo a condensare il loro pensiero: il fascismo è stato un regime dittatoriale precipitato in catastrofe, non può essere banalizzato in questo modo. In nessun modo. Vi sembrerà incredibile, ma non tutto fa spettacolo nella vita.
- Dettagli
di Renato Sacco
L'assemblea applaude un uomo di mezza età che
- Dettagli

Possibile che dopo solo due anni di governo il Presidente degli USA riconosca che ha delle responsabilità
e pensi di cambiare, di ascoltare la frustrazione del suo popolo, di collaborare con i suoi avversari politici...
e noi in Italia ne abbiamo uno che non riconosca mai i suoi errori da almeno sedici anni a questa parte?!
- Dettagli
Un amico fedele
Un amico fedele
è un balsamo nella vita,
è la più sicura protezione.
Potrai raccogliere tesori d'ogni genere
ma nulla vale quanto un amico sincero.
Al solo vederlo, l'amico suscita nel cuore
una gioia che si diffonde in tutto l'essere.
Con lui si vive una unione profonda
che dona all'animo gioia inesprimibile.
Il suo ricordo ridesta la nostra mente
e la libera da molte preoccupazioni.
Queste parole hanno senso
solo per chi ha un vero amico;
per chi, pur incontrandolo tutti i giorni,
non ne avrebbe mai abbastanza.
- Dettagli
Deserto significa vuoto, ma spesso alle persone sembra che la vita quotidiana sia molto più vuota del deserto. Hanno sì una serie di esperienze, sentono un mucchio di notizie nuove, ma tutto ciò alla fine non dice loro nulla di particolare, che valga l'attenzione. Dopo un po' di tempo giungono alla conclusione che è meglio non prestare attenzione a nulla e vivere nell'indifferenza.
Questo, poi, porta alcune persone a cercare un qualche deserto in cui risuoni una voce completamente diversa. La scontentezza del mondo è allora l'inizio di una fuga dalla vita pubblica nella solitudine. Nella storia conosciamo periodi in cui tentativi come questi si manifestavano come movimenti di massa. Alla fine del quinto secolo un autore egiziano sospirava che le città si svuotavano, mentre il deserto si riempiva di persone. Di eremiti allora ce n'erano migliaia e i monasteri sorgevano da tutte le parti e, malgrado ciò, non riuscivano ad accettare tutti quelli che volevano entrarvi, per insufficienza di posti.
Ma è necessario comprendere questa fuga dal mondo in senso cristiano. Un osservatore profano pensa che le persone entrino in convento per un amore infelice, per un fallimento finanziario, per l'insuccesso in un'impresa, per l'incapacità di contrarre legami normali con le persone. A volte queste circostanze sono davvero occasioni di riflessione, ma di per sé non sono una ragione sufficiente a sentire la vocazione a vivere con Dio nella solitudine. Anzi, il cattivo carattere è un grosso ostacolo alla vocazione religiosa. Chi non riesce ad andare d'accordo con gli altri di solito non trova la pace neanche quando è solo con se stesso.
- Dettagli
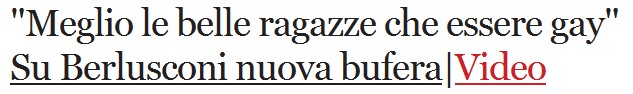
Lui è quel che è...
ma dal video si sente che - con un certo imbarazzo -
più d'uno ha applaudito alla sua "battuta".
In tutti i campi c'é sempre qualche cortigiano interessato che dà risalto alle stupidità.
- Dettagli
di Luisito Bianchi
(...) Cominciavamo con la grande processione al cimitero, che si muoveva dalla chiesa dopo il canto dei vespri in onore dei Santi con subito attaccato quello in suffragio dei Morti, e che s'ingrossava man mano che passava davanti alle osterie, quasi una processione da venerdì santo. Poiché l'arciprete non portava nessuna reliquia e tanto meno l'ostensorio ma solo il breviario, come lo si vedeva spesso quando andava da privato a passeggio per i campi, la gente si prendeva licenza di parlare, gli uomini però a capo scoperto se non piovigginava, e le donne con la corona del rosario in mano, perché una processione era sempre una processione, soprattutto quando c'erano di mezzo i morti che, a non nominarli da vivi, meritavano sempre rispetto. Noi ragazzi imitavamo gli adulti, sempre pronti però a rispondere alle avemarie e ai requiemeternam quando il curato, su e giù a fianco della nostra compatta falange per incuterci il senso della preghiera, ci passava vicino. Accanto all'arciprete c'era quasi sempre un prete forestiero e, per essere giusti, anche l'arciprete chiacchierava, a volte perfino sorrideva, nonostante il breviario in mano. Il prete forestiero era ingaggiato per il discorso al cimitero, che sbracciava dall'alto d'uno sgabello, il quale sgabello era puntellato per qualche secondo dal piede del sacrista, all'occasione in sottana nera filettata di rosso, con tanto di cotta, e poi progressivamente abbandonato alla buona sorte e alle capacità d'equilibrista del prete, dato che lui doveva con la borsa di cuoio in mano girare e rigirare fra l'Uditorio per raccogliere le spese degli uffici della novena dei morti, detta novenone, e del discorso tenuto dal prete forestiero. Il quale prete, se aveva voce tonante o parlava di vedove e di orfani da strappare qualche lacrima, attirava parecchi cerchi concentrici attorno a sé, ma se la voce era deboluccia e la spendeva tutta per la risurrezione della carne, allora cominciavano le donne a cercare, con piedi e gomiti, d'aprirsi la strada per le tombe dei loro cari, e sussurravano: «Scusate, si fa tardi, ho da preparare la cena». Gli uomini, non avendo la cena da preparare e non essendo buoni a mettere fiori e cerini sulle tombe, dovevano stare lì, a fare finta d'ascoltare la predica e di cercare in chissà quante tasche la moneta che non doveva essere troppo leggera perché il sacrista l'avrebbe capito dal tonfo nella borsa, e meglio, porco qui e vacca là, non avere critiche in giro per 10 o 20 centesimi in più. Liberi dagli occhi di tutti, cominciava il nostro gioco. Pulivamo candelette e lumini posti sulle tombe dalla cera scolata. Se la cera era già indurita, cercavamo di mollificarla al calore dello stoppino acceso, poi l'avvoltolavamo nel palmo della mano per amalgamarla; e subito dentro, nella tasca della giacca. Che danno potevamo fare ai morti mettendo in tasca gli ultimi avanzi di lumini e le lacrime raggrumate delle candele? C'era, naturalmente, il più e il meno fortunato ma la Rosina fruttivendola, che vendeva lumini e raccoglieva gli avanzi di cera, non faceva preferenze e a noi che le rovesciavamo le tasche su un foglio di giornale dava a tutti, indistintamente, una manciata di castagne secche. A ripensarci, credo che la Rosina non avesse nessun tornaconto, anzi ci rimettesse; forse era il suo modo di chiedere scusa ai morti perché teneva aperto il suo negozietto per via dei lumini. Ma voi, cari, avete mai succhiato castagne secche per ammorbidirle un poco prima di tentare coi denti, che siano state guadagnate con la vostra intraprendenza sui morti, dato che coi vivi non è come adesso che danno ai ragazzi mille lire come a noi scapaccioni? Se si, converrete con me che un gusto simile nessuna castagna secca comperata in negozio l'ha mai avuto, a girare tutto il mondo.
- Dettagli
di Jean-Luc Garin
«Quando Gesù vide tutta la folla che lo seguiva...» Tutto è cominciato da uno sguardo rivolto alle persone. Le azioni del Signore
- Dettagli
"Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri". "Non prendete né bisaccia, né mantello, né oro, né argento, né bastone, né spada
- Dettagli
di Carlo Maria Martini
Si discute molto su come interpretare il Concilio Vaticano II. Continuità o discontinuità con la tradizione? Ritengo che si tratti di una polemica sterile. Non le pare che la vera chiave di lettura del Concilio Vaticano II, quasi cinquant'anni dopo, consista nel rileggere l'esperienza cristiana alla luce delle sue origini contenute nel Nuovo Testamento? (Antonio Meli, Messina)
È vero! A ormai quasi cinquant'anni dalla celebrazione del Concilio Vaticano II si discute ancora sulla sua interpretazione. Io sono d'accordo con lei che si tratta, almeno in parte, di una polemica sterile, ma anche un po' inevitabile. Ricordo bene quei giorni, perché, pur non essendo membro del Concilio, vivevo a Roma al Pontificio Istituto Biblico, dove risuonavano in vari modi gli echi suscitati dalle discussioni dei vescovi. Si temeva che il Concilio promovesse alcune interpretazioni letterali o simboliche della Scrittura che sistematicamente respingevano ogni sorta di lettura storico-critica. Alcuni sostenevano addirittura che i metodi critici portassero alla perdita della fede. Di fatto molti esegeti sostenevano invece un'interpretazione dei testi che nutrisse la fede, ma fosse anche attenta agli studi storico-critici. Fu grande quindi la loro gioia quando, dopo lunghe e accese discussioni, fu approvata la Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione. Ma per molti c'era un motivo di gioia ancora più grande. I documenti approvati dai Padri conciliari dimostravano nel loro insieme la volontà della Chiesa di entrare in contatto con tutti gli uomini di buona volontà e di porsi in atteggiamento di rispettoso ascolto delle voci e dei desideri di tutti. Naturalmente non è in questo entusiasmo che troviamo lo spirito del Concilio. Anche perché in quel periodo, in un'atmosfera di entusiasmo e anche con una certa ingenuità, circolavano tanti progetti per il futuro della Chiesa. Cosa dunque appartiene o no allo spirito del Concilio? È opportuna la distinzione tra continuità e discontinuità della tradizione. I sostenitori di un'interpretazione rigida, che guardano con sospetto ad ogni novità, non tengono ben presente che vi possono essere novità nella Chiesa. Essa è un organismo vivente, che nasce piccolo ma nel tempo si sviluppa come un corpo umano che cresce così da apparire come qualcosa di nuovo. Tale visione della storia della Chiesa fu sostenuta fin dal secolo V da San Vincenzo di Lerino. Egli afferma che nella Chiesa vi saranno certamente nel corso degli anni progressi anche molto vistosi. Non ci si deve spaventare di essi. Solo quando un organismo si trasforma in un altro bisognerà parlare di cambiamenti e respingerli con forza. Come scrive San Vincenzo di Lerino: «È necessario dunque che, con il progredire del tempo, crescano e progrediscano quanto più possibile la comprensione, la scienza e la sapienza, così nei singoli come di tutti, tanto di uno solo, quanto di tutta la Chiesa». Il suggerimento del lettore che parla di «rileggere l'esperienza cristiana alla luce delle sue origini contenute nel Nuovo Testamento» mi pare conforme con quanto abbiamo detto parlando di quali novità possa esprimere la Chiesa nel corso dei secoli.






